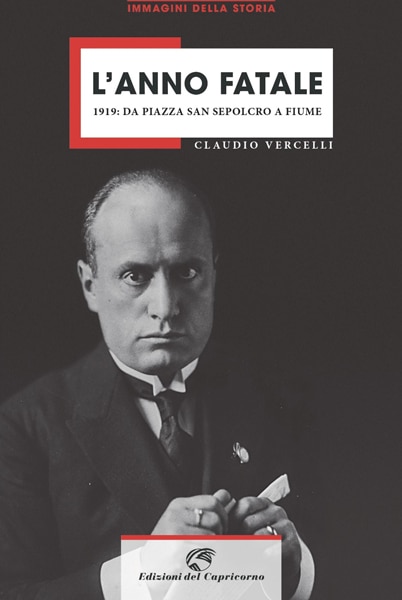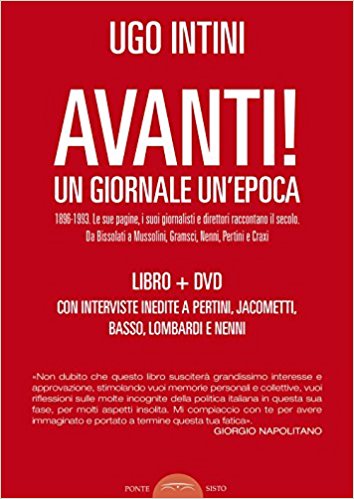Gli anniversari sono facili pretesti per far scattare la “trappola del primato”. Di lì, nel rimembrare uno scrittore, proliferano i ricordi, le celebrazioni, le colonne dei giornali ne elencano a cascata le opere spendendo per ognuna due cenni e una formula, escono nuovi libri di e sul soggetto, e le parole riddano attorno alla donna o all’uomo da evocare alla ricerca di sciocchi primati assoluti o relativi (il Tizio è stato il primo a… il migliore fra chi…; o uno dei più importanti scrittori… e così via).
Pasolini arginava Pavese nelle terre della medietà, se non della mediocrità: un artista dell’impegno corretto, un antifascista che si era adeguato, specie dopo la guerra, ai valori della Resistenza. Senza averla fatta. Ma infine uno scrittore che non suscita grandi problemi né letterari né politici.
Come Beppe Fenoglio, di lui più giovane di quattordici anni, Pavese si trovava a Roma nel settembre del 1943, non per il servizio militare ma su invito di Giulio Einaudi per occuparsi delle faccende relative all’apertura di un ufficio della casa editrice nella capitale. Al ritorno a Torino non trovò molti amici e colleghi, saliti in montagna per unirsi ai ribelli. E poi chissà.
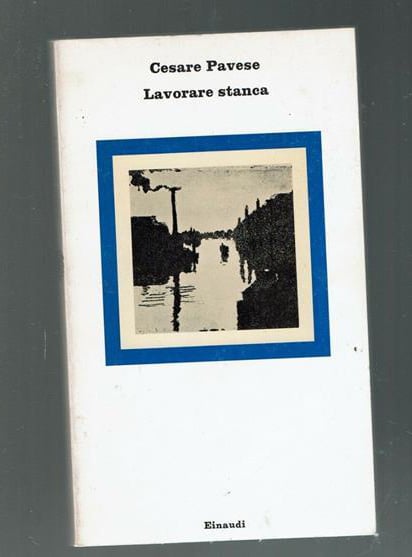 Si direbbe che Pavese abbia perso l’Occasione della vita, quella con la lettera grossa davanti. Occasione che altri, più vicini a lui nella geografia e nella biografia, avevano colto. Fenoglio, di nuovo, che disse di sé – o forse fu qualcun altro a dirlo, non ricordo – di aver vissuto il darsi partigiano come cesura della biografia fatta anima, una tmesi che gli permise di dire ch’ebbe quasi due vite, una prima e uno dopo la guerra. Fenoglio ebbe modo così di combattere la propria titanomachia: che è lotta contro il nemico per eccellenza ma anche opportunità di conoscere se stesso.
Si direbbe che Pavese abbia perso l’Occasione della vita, quella con la lettera grossa davanti. Occasione che altri, più vicini a lui nella geografia e nella biografia, avevano colto. Fenoglio, di nuovo, che disse di sé – o forse fu qualcun altro a dirlo, non ricordo – di aver vissuto il darsi partigiano come cesura della biografia fatta anima, una tmesi che gli permise di dire ch’ebbe quasi due vite, una prima e uno dopo la guerra. Fenoglio ebbe modo così di combattere la propria titanomachia: che è lotta contro il nemico per eccellenza ma anche opportunità di conoscere se stesso.
Diversa fu la parabola di Pavese. Nel 1943 non giocò la carta prevedibile, quella che l’avrebbe portato a farsi scrivere sulla tomba il titolo di partigiano o, con massima catarsi, a “finire con una pallottola in testa, sulla collina”. Queste ultime parole non sono mie né di Pavese. Le scrisse Umberto Eco quando, nel Pendolo di Foucault, creò il personaggio di Jacopo Belbo, tra le altre cose alter ego di Pavese, traslandone nel cognome l’indicazione del toponimo di Santo Stefano Belbo. Ci nacque il 9 settembre del 1908, Cesare Pavese, e qualche anno più tardi la mamma, rimasta vedova, vendette la casa per trasferirsi a Torino.
 Quasi tutti dicono che a Torino vivesse come una creatura irrequieta, difficile, senza gioie. Prima e dopo la guerra, non fa differenza. Il Belbo di Umberto Eco, sfrondando, restituisce il ritratto di un uomo incompiuto che, perduta l’Occasione della vita, la rincorre per il resto dei giorni senza mai lambirla.
Quasi tutti dicono che a Torino vivesse come una creatura irrequieta, difficile, senza gioie. Prima e dopo la guerra, non fa differenza. Il Belbo di Umberto Eco, sfrondando, restituisce il ritratto di un uomo incompiuto che, perduta l’Occasione della vita, la rincorre per il resto dei giorni senza mai lambirla.
 Cesare Pavese, terminata la guerra, si iscrisse al Partito comunista, pubblicò Il compagno e Col compagno intitolò quei Dialoghi ideati per la rubrica che tenne sul quotidiano L’Unità. Un eccesso pletorico, forse. Uno sgargiante modo di dire che l’impegno c’era, anche se giunto tardi. D’effetto, ma un po’ fittizio, come la lampadina di Hitchcock affondata nel bicchiere di latte per renderlo incredibilmente bianco. La serissima affettazione che aveva fatto storcere il naso a Pasolini.
Cesare Pavese, terminata la guerra, si iscrisse al Partito comunista, pubblicò Il compagno e Col compagno intitolò quei Dialoghi ideati per la rubrica che tenne sul quotidiano L’Unità. Un eccesso pletorico, forse. Uno sgargiante modo di dire che l’impegno c’era, anche se giunto tardi. D’effetto, ma un po’ fittizio, come la lampadina di Hitchcock affondata nel bicchiere di latte per renderlo incredibilmente bianco. La serissima affettazione che aveva fatto storcere il naso a Pasolini.
Perché Pasolini pensava all’ingaggio politico in maniera differente. Una faccenda diretta, da toccare con mano. Cesare Pavese era invece uomo della distanza. Non del distacco ma del divario utile al controllo e alla disciplina.
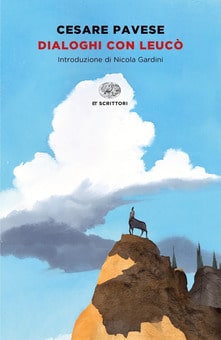 Quando, dopo alcuni anni di insegnamento, iniziò a lavorare all’Einaudi seguiva un ferreo programma: sveglia alle cinque del mattino, scrittura fino alle otto e poi, una volta varcata la porta della casa editrice, lavoro sui manoscritti fino al pomeriggio, senza lasciare spazio ad altro.
Quando, dopo alcuni anni di insegnamento, iniziò a lavorare all’Einaudi seguiva un ferreo programma: sveglia alle cinque del mattino, scrittura fino alle otto e poi, una volta varcata la porta della casa editrice, lavoro sui manoscritti fino al pomeriggio, senza lasciare spazio ad altro.
Difficilmente sorrideva. Tra una sigaretta e l’altra, mento e zigomi spigolosi come il carattere, le labbra piegate verso il basso, afferrava la penna stilografica e scriveva una lettera di lavoro, o un appunto, o bisbigliava toccandosi gli occhi arrossati dal fumo. Se il sole gli arrivava sul volto in maniera diretta non era più possibile vedergli lo sguardo perché le lenti si cambiavano in grosse monete d’argento appena coniate.
 Il suo impegno non era quindi direttamente politico (faccenda che rese quasi una burla il confino a Brancaleone Calabro, nel 1935, quando gli furono trovate tra le mani alcune lettere compromettenti, che neppure aveva letto). Cesare Pavese l’impegno lo faceva nel sugo dei libri suoi e degli altri, nello svellere la cultura dalle antiche radici, non sempre foriere di cose eccelse. La cercava lì l’Occasione della vita, nel silenzio della stanza, nella prassi della scrittura quotidiana che per lui fu il destro per sferrare un calcio al fanatico nazionalismo con la creazione del nuovo mito americano, fatto di democrazia, forse più ideale che reale, e di cose chiare e tonde, di cose dette e fatte e poi raccontate, di nomi precisi che risuonano nelle sue pagine, tanto diverse dai calligrafismi e dai lirismi italiani, e più simili all’asprezza di una saponetta rosa lasciata a seccare sotto il sole. Nel riprenderla a sera tra le mani sembra fatta di spine. Così è la Parola di Pavese, frutto del mestiere (di vivere e di soffrire), della fatica, del lavoro di chiarificazione del mito.
Il suo impegno non era quindi direttamente politico (faccenda che rese quasi una burla il confino a Brancaleone Calabro, nel 1935, quando gli furono trovate tra le mani alcune lettere compromettenti, che neppure aveva letto). Cesare Pavese l’impegno lo faceva nel sugo dei libri suoi e degli altri, nello svellere la cultura dalle antiche radici, non sempre foriere di cose eccelse. La cercava lì l’Occasione della vita, nel silenzio della stanza, nella prassi della scrittura quotidiana che per lui fu il destro per sferrare un calcio al fanatico nazionalismo con la creazione del nuovo mito americano, fatto di democrazia, forse più ideale che reale, e di cose chiare e tonde, di cose dette e fatte e poi raccontate, di nomi precisi che risuonano nelle sue pagine, tanto diverse dai calligrafismi e dai lirismi italiani, e più simili all’asprezza di una saponetta rosa lasciata a seccare sotto il sole. Nel riprenderla a sera tra le mani sembra fatta di spine. Così è la Parola di Pavese, frutto del mestiere (di vivere e di soffrire), della fatica, del lavoro di chiarificazione del mito.
È l’uomo dei simboli, anche, che sono la carne del mito e ne trascrivono l’essenza. La sua vita è fatta di simboli. Non beveva vino rosso, mai. Se con gli amici passava una giornata sulle colline e poi giungevano a una trattoria a buon mercato, una piola, per mangiare, la prima cosa che faceva entrando era quella di chiedere se servivano il bianco. Altrimenti era capace di rimettersi il paltò e uscire. Il vino rosso era il sangue, insegna mitica di una violenza tellurica che lo angosciava.
 Non fece la guerra perché non sarebbe riuscito a dare un nome alle cose e agli eventi. Troppi e troppo tumultuosi. Cesare Pavese era un monocorde ossessivo. Sedeva in treno e guardava le colline, drammatiche e solenni come il seno sparto di un’indocile divinità. E non c’era volta che le colline non gli ricordassero una mammella, una madre, una donna. Era l’uomo del rituale, della monotonia. “La monotonia è un pegno di sincerità” scriveva. Così ogni volta che negli occhi gli entrava la collina-mammella poteva approfondire il senso di quel segnacolo e carpirne l’affiorante realtà segreta. Come la lingua che seguita a battere dove il dente pulsa. Solo la ripetizione del gesto potrà forse rendere conto della forma del dolore. O della paura.
Non fece la guerra perché non sarebbe riuscito a dare un nome alle cose e agli eventi. Troppi e troppo tumultuosi. Cesare Pavese era un monocorde ossessivo. Sedeva in treno e guardava le colline, drammatiche e solenni come il seno sparto di un’indocile divinità. E non c’era volta che le colline non gli ricordassero una mammella, una madre, una donna. Era l’uomo del rituale, della monotonia. “La monotonia è un pegno di sincerità” scriveva. Così ogni volta che negli occhi gli entrava la collina-mammella poteva approfondire il senso di quel segnacolo e carpirne l’affiorante realtà segreta. Come la lingua che seguita a battere dove il dente pulsa. Solo la ripetizione del gesto potrà forse rendere conto della forma del dolore. O della paura.
Cesare Pavese aveva paura di fare scelte definitive. Non perché fosse un codardo ma perché la sua stessa vita era fatta di dicotomie, di ambivalenze, di tagli obliqui. Scegliere avrebbe significato mutilare un brano di sé. Impegno e disimpegno. Campagna e città. Solitudine e desiderio di comunione, infanzia e età adulta. Guerra e pace. Scelse di non fare la guerra vera ma portò la guerra dentro di sé, scatenata dai sensi di colpa che lanciavano bombe senza ultimatum, dalla percezione di inadeguatezza morale, culturale, umana, erotica, dalla rognosa solitudine. Apparentemente si può dire che la sua esistenza sia avanzata sulle mosse dell’anacoluto, sul tema sospeso dell’adesione a un progetto elusivo.
Terra e guerra per Cesare Pavese rimarono non solo nel suono. Di entrambe percepiva la realtà sessuale, ferina, violenta. Per faticare sulla terra così come per sparare a un nemico occorre essere invasati, occorre annusare l’odore del sangue, del fuoco, della foia. Occorre porsi fuori dal tempo per zappare e per combattere. E anche per amare. Tutte cose di cui Cesare Pavese, a suo dire, non era capace.

Era un uomo triste. Quasi sempre. Di lui non ricordo alcun ritratto né fotografia che lo colga a sorridere. Solo una, presa nel giugno del 1950 durante la premiazione dello Strega. È in piedi, la mano sinistra nella tasca della giacca, la destra raccolta in un pugno lasco. Guarda il vuoto, la testa reclinata leggermente, le labbra appena fissate in un sorriso incompiuto. È in compagnia di una donna molto bella, in abito chiaro, che fuma, beve, chiude gli occhi e ride, le braccia nude e nude le mani spogliate dei guanti. È Doris Dowling, sorella minore di Constance di cui lo scrittore è perdutamente innamorato. Fu Doris ad accompagnarlo al ninfeo di Villa Giulia a Roma (quanto gli mancava Constance?), fu lei che Cesare Pavese cercò per tutta la sera, con gli occhi. L’avrebbe implorata di dirgli un’altra verità, che Constance sarebbe tornata da lui. Invece non tornò mai.
Quel mezzo sorriso di Pavese era l’esibizione del turbamento oscuro e misterioso, quello che gli suscitavano il vino nero, di cui aveva timore, e la guerra, ma del quale era infine riuscito a trovare la chiave. “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, quelli di Constance. Cesare Pavese si era deciso per la morte e per quello sguardo perduto di cui tuttavia si sarebbe riappropriato suggellandolo nei primi battiti della propria eternità.
 Voleva respirare, togliendosi di dosso quel grumo di fatti interiori che lo stava soffocando. Il mondo esterno gli entrava come un liquido ed egli non trovava modo di farlo uscire. Diventava mito. Ma ne soffriva. Due volte forse solo trovò il destro per vomitare fuori quel bolo interiore, liberandosene: quando si tolse la vita e, molti anni prima, quando a Torino, passeggiando con un’amica, trovò per strada un rondone spaesato. Lo raccolse tra le mani, salì le scale di un vecchio palazzo e giunto sul tetto liberò l’uccello nel cielo.
Voleva respirare, togliendosi di dosso quel grumo di fatti interiori che lo stava soffocando. Il mondo esterno gli entrava come un liquido ed egli non trovava modo di farlo uscire. Diventava mito. Ma ne soffriva. Due volte forse solo trovò il destro per vomitare fuori quel bolo interiore, liberandosene: quando si tolse la vita e, molti anni prima, quando a Torino, passeggiando con un’amica, trovò per strada un rondone spaesato. Lo raccolse tra le mani, salì le scale di un vecchio palazzo e giunto sul tetto liberò l’uccello nel cielo.
Dicono che mai prima di allora fu tanto felice.
Giacomo Verri, scrittore
Pubblicato mercoledì 9 Settembre 2020
Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/cesare-pavese-limpegno-ovvero-la-scrittura/