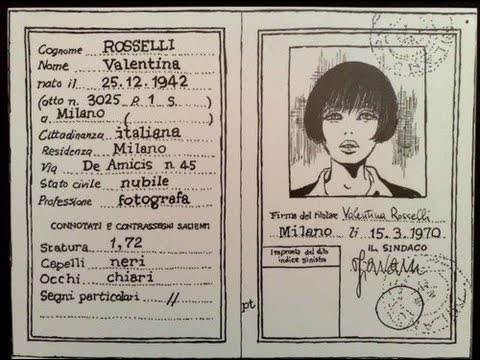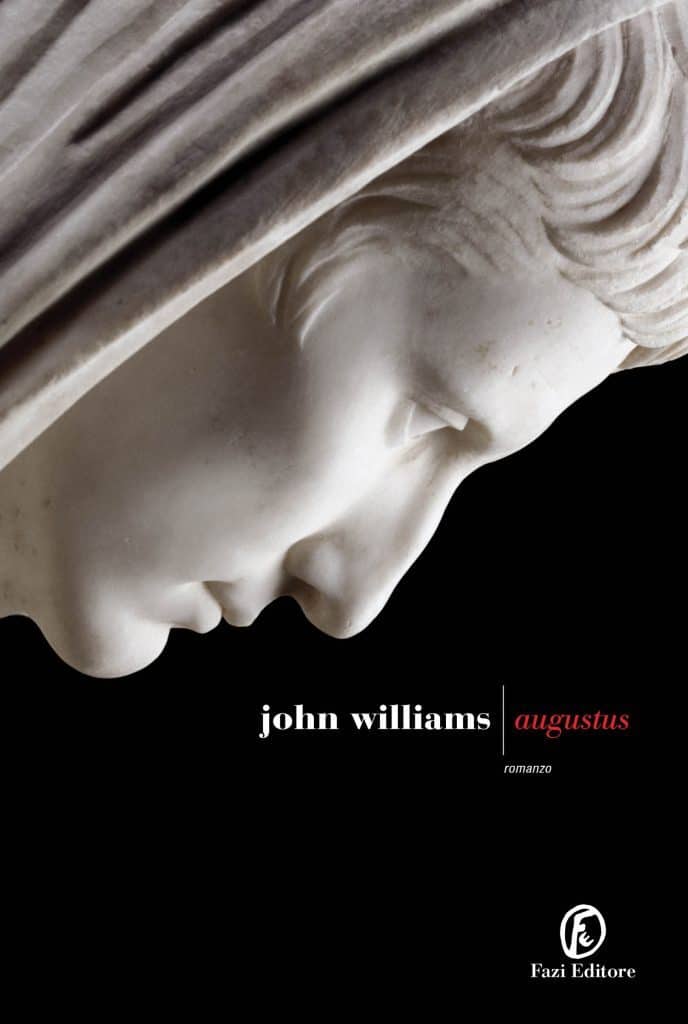 Nel lustro appena trascorso, John Williams si è imposto al pubblico italiano e internazionale grazie a quel libro, Stoner, considerato da più parti il “romanzo perfetto” della letteratura americana: pubblicato nel 1965 negli States, fece allora registrare un mediocre risultato di vendite (circa 2000 copie) per poi godere di una grandiosa, ancorché postuma, rivalsa nei primi due decenni del nostro XXI secolo, quando le pagine di Williams hanno oltrepassato i confini nazionali, raggiungendo il milione di copie.
Nel lustro appena trascorso, John Williams si è imposto al pubblico italiano e internazionale grazie a quel libro, Stoner, considerato da più parti il “romanzo perfetto” della letteratura americana: pubblicato nel 1965 negli States, fece allora registrare un mediocre risultato di vendite (circa 2000 copie) per poi godere di una grandiosa, ancorché postuma, rivalsa nei primi due decenni del nostro XXI secolo, quando le pagine di Williams hanno oltrepassato i confini nazionali, raggiungendo il milione di copie.
In vita, tuttavia, Williams (1922-1994) ottenne maggiori soddisfazioni da Augustus, il suo ultimo lavoro (se si esclude l’incompiuto The Sleep of Reason) che vinse, nel 1973, il National Book Award, ex aequo con Chimera di John Barth. Il romanzo era già stato tradotto in Italia, all’indomani del premio, da Sperling & Kupfer nel 1974 nella traduzione dello straordinario e prolifico Bruno Oddera (riproposto poi da Frassinelli nel 1984 e da Castelvecchi nel 2013); oggi torna sui nostri scaffali – e, aggiungiamo, trova la sua migliore collocazione – tra i libri pubblicati da Fazi (pp. 409, € 18), l’editore che ha “riscoperto” Williams nel 2012 e che da allora sta procedendo alla pubblicazione dell’opera omnia (almeno quella in prosa) dello scrittore americano, attraverso una serie di riuscitissime traduzioni affidate a Stefano Tummolini.
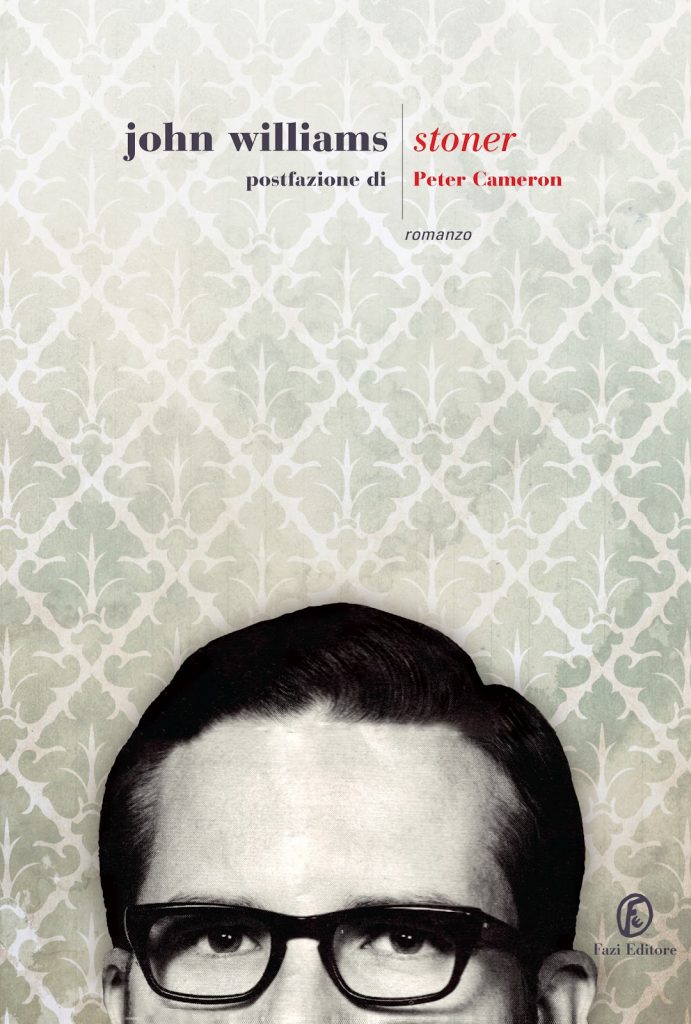 Augustus è, apparentemente, un libro molto diverso da Stoner. Qui abbiamo un romanzo storico-epistolare che dà voce a decine di personaggi – Ottaviano, Mecenate, Cicerone, Marco Antonio, Giulia, Ottavia, Cleopatra, ecc. – sullo sfondo di quella Roma di duemila anni fa, “la città più straordinaria del mondo, nella più straordinaria delle epoche”. Il ritratto scolpito nelle quattrocento pagine è quello di Ottaviano Augusto, il padrone del mondo, colui che “ha assicurato la prosperità all’urbe e alle campagne” e ha donato ai cittadini di Roma una pace prolungata. Tuttavia, anche se Augustus non canta la necessaria monotonia di un’esistenza qualunque come sarà quella di William Stoner – negletto docente dell’Università del Missouri – la vicenda di Cesare Ottaviano resta la semplice storia di un uomo: un uomo solo con i propri sogni e le proprie paure; anche se quei sogni e quelle paure erano la creazione di un colossale potere e la fatica del suo mantenimento tra le pastoie di crimini necessari, di pettegolezzi divenuti stile di vita, di matrimoni contratti per ragion di stato. Augustus come Stoner – non a caso i due romanzi recano come titolo il nome del protagonista – è il ritratto di un’esistenza spesa e consumata progressivamente nella solitudine. Che l’uomo sia grande o piccino, agli occhi della Storia poco importa; quel che conta è che in Williams l’essere umano viene accolto nella specola precisa del narratore e restituito, nudo e solitario, al lettore. In principio Augusto è solo un giovinetto simpatico, “nulla di più, con un viso troppo delicato per reggere i colpi del destino, dei modi troppo diffidenti per riuscire a imporsi, e una vocina troppo flebile per parlare come un condottiero”. Attorno a lui ci sono alcuni amici, Marco Agrippa, Mecenate, Salvidieno Rufo. Il futuro Cesare viene incredibilmente sottovalutato dai propri “rivali” – primo fra tutti Cicerone, l’illuso – sulla scorta di anacronistici entusiasmi o di troppo belle ostinazioni, quando allora, a Roma, contavano solo il calcolo, la politica e la necessità.
Augustus è, apparentemente, un libro molto diverso da Stoner. Qui abbiamo un romanzo storico-epistolare che dà voce a decine di personaggi – Ottaviano, Mecenate, Cicerone, Marco Antonio, Giulia, Ottavia, Cleopatra, ecc. – sullo sfondo di quella Roma di duemila anni fa, “la città più straordinaria del mondo, nella più straordinaria delle epoche”. Il ritratto scolpito nelle quattrocento pagine è quello di Ottaviano Augusto, il padrone del mondo, colui che “ha assicurato la prosperità all’urbe e alle campagne” e ha donato ai cittadini di Roma una pace prolungata. Tuttavia, anche se Augustus non canta la necessaria monotonia di un’esistenza qualunque come sarà quella di William Stoner – negletto docente dell’Università del Missouri – la vicenda di Cesare Ottaviano resta la semplice storia di un uomo: un uomo solo con i propri sogni e le proprie paure; anche se quei sogni e quelle paure erano la creazione di un colossale potere e la fatica del suo mantenimento tra le pastoie di crimini necessari, di pettegolezzi divenuti stile di vita, di matrimoni contratti per ragion di stato. Augustus come Stoner – non a caso i due romanzi recano come titolo il nome del protagonista – è il ritratto di un’esistenza spesa e consumata progressivamente nella solitudine. Che l’uomo sia grande o piccino, agli occhi della Storia poco importa; quel che conta è che in Williams l’essere umano viene accolto nella specola precisa del narratore e restituito, nudo e solitario, al lettore. In principio Augusto è solo un giovinetto simpatico, “nulla di più, con un viso troppo delicato per reggere i colpi del destino, dei modi troppo diffidenti per riuscire a imporsi, e una vocina troppo flebile per parlare come un condottiero”. Attorno a lui ci sono alcuni amici, Marco Agrippa, Mecenate, Salvidieno Rufo. Il futuro Cesare viene incredibilmente sottovalutato dai propri “rivali” – primo fra tutti Cicerone, l’illuso – sulla scorta di anacronistici entusiasmi o di troppo belle ostinazioni, quando allora, a Roma, contavano solo il calcolo, la politica e la necessità.
Alla morte di Giulio Cesare, il giovane Augusto cambia, su di lui scende una gelida tristezza che lo rende solitario e misterioso accattivandogli, però, l’immaginazione di Roma. L’ebbrezza del potere si fa strada contro la piccineria della corruzione quotidiana, contro gli intrighi del Senato, contro i capricci delle alleanze. Augusto vince tutti, manipola – almeno in apparenza – il lato più affascinante e confabulato della politica romana carpendo i segreti di quella civiltà edificata sul pragmatismo, riuscendo infine a opporsi, a volte, alle spietate esigenze della necessità, altre ad assecondarle.

Ma quest’uomo, che ha deliberatamente deciso di operare sulla debolezza di Roma anteponendola a tutto il potere d’Oriente – che aveva invece ammaliato il nemico Antonio: “a Oriente c’è solo un bottino da saccheggiare; ma a Occidente c’è il mondo, e un potere tale che solo i grandi possono concepirlo” – quest’uomo, dicevo, è davvero un vincitore? Cosa sa, Augusto, cosa vede, cosa sente, cosa lo muove? “Ignoro dove stiamo andando, mentre conduco la patria verso il suo destino”. Quel ragazzo sprovveduto, assieme agli amici più fidati, si affaccia su un abisso senza fondo, schiavo della ragion di stato e delle proprie ambizioni, consapevole che l’avvenire di Roma sarebbe divenuto più importante di lui stesso.
Ma dove sta il Bene? Roma è diventata migliore grazie ad Augusto? E il Cesare medesimo, quali vantaggi ne ha tratto? La pace dell’Urbe si volta in un mondo dove tutto è potere, dove si ama e si muore per il potere; dove gli stadi levano boati per la presenza di un uomo, dove le donne sono schiave di matrimoni combinati, dove tutti sussurrano tra la ricchezza e la noia, dove ognuno, abbandonato al lusso e ai piaceri, s’indebolisce in attesa che il barbaro invasore distrugga tutto. Il sogno di Roma diventa una grande menzogna nella quale è difficile mantenere l’onestà dei cuori.
Williams ci consegna il ritratto di un uomo progressivamente infelice, che in politica ha vinto, certo, ma nell’intimo del proprio animo è reduce dalla vita e da se stesso: egli ha guerreggiato per conservare un barlume di coscienza del Bene, ha sacrificato i propri cari, ha sofferto per l’assenza di amore, giungendo, infine, a comprendere quanto il governo del mondo sia poca cosa, quanto ogni uomo, nell’ultimo giorno, finisca per trasformarsi nella caricatura di se stesso. E a rendere ancor più intensa e vera la parabola esistenziale di Augusto concorrono tutte le voci che Williams gli costruisce attorno e in specie quella della figlia Giulia le cui pagine di Diario, dalle brevi sponde dell’isola di Pandataria, dov’è confinata per adulterio, sono forse tra le più indimenticabili che il romanzo ci regala. Donna per eccellenza, fine conoscitrice dell’arte della seduzione – più della stessa Cleopatra – Giulia emancipa se stessa e il proprio corpo consumando come cera al vento il potere che il sangue paterno e i contratti famigliari le hanno assegnato. Augusto la esilia, ma da padre la ama fino in fondo, entrambi divenendo consapevoli che “la perdita è la condizione ineludibile” delle nostre esistenze.

Augusto, come Stoner, è un uomo del nostro tempo, è un filosofo che col corpo ha cercato sollievo da se stesso tra le braccia di qualche donna, ma che poi, alla fine dei giorni, ha scoperto nella mente – come quel mediocre successore dell’Università del Missouri – che esiste un altro amore, quello dei poeti nei confronti dei loro testi, quello per la cultura, quello per i libri, “un amore così puro che non necessita di alcun oggetto vivente”. Nella vecchiaia di Augusto si legge il medesimo fatalismo, reso però più buio dalla constatazione che la servitù al potere non consente quegli olimpici e intensi innamoramenti che al professor Stoner permetteranno, invece, di ricevere il Bene anche nelle situazioni più tragiche che la vita gli prescriverà.
In lui pure permane, però, una residuale saggezza, concentrata nelle ultime lettere di questo romanzo epistolare, quelle che Augusto scrive per il caro amico Nicola di Damasco, lettere che, come la filologia per Stoner, rappresentano l’estrema pratica etica che pone un argine a quelle presunzioni degli individui e del mondo.
Il giovane che non conosce il futuro vede la vita come un’avventura eroica, un’Odissea attraverso mari misteriosi e isole ignote, dove mettere alla prova i suoi poteri, per scoprire la propria immortalità. L’adulto, che ha vissuto il futuro che sognava, vede la vita come una tragedia; perché ha imparato che il suo potere, per quanto grande, non prevarrà contro quelle forze del caso e della natura a cui diede i nomi degli dèi: e ha imparato di essere mortale. Ma il vecchio, se recita a dovere la sua parte, non può che vedere la vita come una commedia. Perché in lui vittorie e fallimenti si confondono, recandogli vergogna e orgoglio allo stesso modo; e non si crede eroe, quando trionfa sopra quelle forze, né si sente vittima, quando ne resta schiacciato. Come la misera, pietosa maschera di un attore, comprende infine di aver interpretato così tanti ruoli da non essere nemmeno più se stesso.
Giacomo Verri, scrittore e insegnante di Lettere. Ha scritto su Nazione Indiana, Doppiozero, Il Primo amore, Nuova Prosa, LibriSenzaCarta, L’impegno. Ha collaborato alle pagine culturali del quotidiano l’Unità, e ora recensisce per Satisfiction e La poesia e lo spirito. Cura la rubrica Radici e Dedali sulla rivista Zibaldoni e altre meraviglie. Partigiano Inverno, testo finalista al Premio Calvino 2011, è stato il suo primo romanzo. Con Racconti partigiani torna a parlare di Resistenza, quella di ieri e quella di oggi. Dal 2016 ha inaugurato un proprio blog letterario: http://giacomoverri.wordpress.com
Pubblicato giovedì 26 Ottobre 2017
Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/ottaviano-augusto-troppi-ruoli-tragedia/