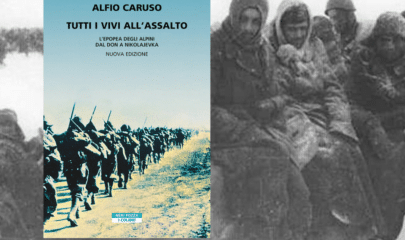I giudici di Bologna hanno svelato le trame di una nuova storia, una storia nascosta. Una storia di tradimenti e di violenze ai danni della democrazia italiana. L’hanno scritta valutando il contesto in cui agirono autori e mandanti della strage del 2 agosto 1980, e analizzando cinquant’anni di tentativi di condizionamento delle libertà costituzionali. Messi in atto da una “struttura occulta” cui concorsero nel dopoguerra una parte significativa degli apparati militari e di sicurezza dello Stato, protetti da esponenti delle forze di governo e appoggiati dagli oltranzisti statunitensi. Chi ne faceva parte affermava di voler di preservare l’Italia dal comunismo, secondo i principi della Guerra fredda. Ma a questo scopo non si esitò a mobilitare e foraggiare, durante decenni, una schiera di ex gerarchi della repubblica sociale di Mussolini, aspiranti golpisti, freddi terroristi, di criminali mafiosi e camorristi. Per i quali la guerra civile non è mai finita: essi furono scagliati contro gli italiani in centinaia di attentati. A partire da Portella della Ginestra, e poi a Piazza Fontana, a Brescia, al treno Italicus, alla stazione di Bologna.

Stragi politiche, stragi di stato. Perché ciascuna di esse fu progettata ed eseguita seguendo una unica strategia eversiva, con la diretta complicità di pubblici ufficiali che, anziché difenderla, tradirono la Costituzione democratica votandosi al suo riassetto in senso autoritario. È una storia “politica e criminale” al tempo stesso; accuratamente occultata, le cui tracce sono state disperse con la sistematica distruzione degli archivi, la manomissione dei documenti, la programmatica falsificazione.
I magistrati della Procura generale e della Corte di assise del capoluogo emiliano l’hanno ricostruita grazie al paziente lavoro di tanti loro colleghi nelle varie Procure d’Italia. L’hanno proposta nelle motivazioni, stese dal giudice Massimiliano Cenni, della recente sentenza con cui i giudici hanno comminato l’ergastolo, sia pure in primo grado, al neofascista reggiano Paolo Bellini, quale quinto appartenente al commando che il due agosto fece esplodere a Bologna la bomba per la quale morirono ottantacinque persone, e almeno duecento rimasero ferite.

Tale sentenza ha fatto seguito a quella che due anni prima aveva concluso il processo ai mandanti dell’eccidio del due agosto, stabilendo come i terroristi fascisti (Valerio Fioravanti, Gilberto Cavallini, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini) abbiano eseguito l’attentato alla stazione su impulso venuto del capo della loggia P2, Licio Gelli. Egli finanziò autori e organizzatori della strage con quindici milioni di dollari, parte delle somme sottratte al Banco Ambrosiano. Complici di Gelli, e del resto come lui da tempo scomparsi, il banchiere Umberto Ortolani e il potentissimo capo dell’Ufficio affari riservati del ministero dell’Interno, Federico Umberto D’Amato, a lungo dominus dei servizi segreti italiani e fedele esecutore delle disposizioni provenienti dagli Stati Uniti.
I magistrati emiliani (il procuratore generale Alberto Candi, e i sostituti Umberto Palma e Nicola Proto) hanno tenuto conto di migliaia e migliaia di pagine scritte a suo tempo dai collegi giudicanti a Milano, Brescia, Venezia, e nella stessa Bologna. Pronunciamenti che spesso, troppo spesso, hanno soltanto potuto sfiorare le responsabilità degli imputati neofascisti, a favore dei quali sono scattate molteplici occulte garanzie e coperture attraverso opportuni depistaggi operati, come secondo un piano preordinato, dagli apparati di sicurezza. Da quelle sentenze emerge tuttavia — hanno riconosciuto i giudici della Corte di assise — come sin dall’inizio (e si parla degli anni Cinquanta) i servizi segreti italiani siano stati perfettamente a conoscenza del progetto eversivo cullato dal terrore nero.
Ma conoscere è dir poco: i servizi condividevano quel progetto, ne erano essi stessi protagonisti, ne reggevano le file cullando al proprio interno attentatori e filo-golpisti. Tutto ciò fu reso addirittura esplicito durante il noto convegno dell’Istituto Pollio (1965) finanziato dal servizio segreto militare Sifar e dai massimi vertici dell’Esercito. I relatori teorizzarono l’esigenza di provocare attentati indiscriminati di cui accusare le sinistre. Una “guerra psicologica” per influenzare l’opinione pubblica e creare le condizioni politiche per una Repubblica autoritaria di tipo presidenziale. Analogo convegno era stato tenuto anni prima a Roma (1960) sotto l’egida della Nato, presenti ministri e parlamentari.

Già a quell’epoca — dunque prima ancora della trasformazione eversiva della P2 — i servizi di sicurezza avevano reintegrato nei propri ranghi coloro che erano stati collaboratori di fascisti e nazisti: così come era avvenuto nella polizia, nelle forze armate, nella magistratura. Falangi di ufficiali dell’Esercito e dei Carabinieri rinnegarono la Costituzione antifascista su cui avevano giurato per votarsi segretamente ad una specie di “costituzione anticomunista”, vera anima del “doppio Stato”. La linea era stata dettata dal capo della Cia statunitense, Allen Dulles, autore del cosiddetto piano “demagnetize”, per il quale la presenza dei comunisti e delle sinistre avrebbe dovuto essere cancellata in tutta Europa, in particolare nel nostro Paese e in Francia.
Da noi l’effetto del convegno Pollio fu quello di potenziare i già esistenti gruppi neofascisti e di fatto arruolarne i militanti quali strumenti operativi del progetto eversivo. Ai circoli di “Pace e Libertà” diretti dall’ex ambasciatore Edgardo Sogno (già medaglia d’oro della Resistenza, ma accanito propugnatore di un progetto di golpe autoritario) si affiancarono dunque gli aderenti a Ordine nuovo, gruppo fondato dal missino Pino Rauti e assai apprezzato all’interno delle forze armate. Il sostegno fu garantito anche a numerose formazioni quali il Fronte nazionale di Valerio Borghese, la Fenice di Milano e Costruiamo l’azione a Roma; mentre ai seguaci di Avanguardia nazionale, fondata da Adriano Tilgher e Stefano Delle Chiaie, furono affidati compiti di provocazione, infiltrazione e raccolta informazioni nei confronti dei movimenti di sinistra, ad uso dell’Ufficio affari riservati di D’Amato. Lo spionaggio fu rivolto anche contro i magistrati della Repubblica, per ciascuno dei quali furono confezionati dossier di tipo ricattatorio: ed è una pratica che la Procura di Roma ha scoperto essere ancora oggi in uso nell’estrema destra.
 A fare da collante dell’intera rete erano i Nuclei per la difesa dello Stato (NdS), di fatto appendice della organizzazione Gladio, struttura paramilitare voluta dal Pentagono (che la battezzò “Stay Behind”, rimanere alle spalle) e rimasta in gran parte segreta. I Nuclei erano guidati da ufficiali, avevano libero accesso alle caserme e agli arsenali, accoglievano militari e civili. Rispetto a Gladio però gli Nds addestravano anche personaggi notoriamente legati ad ambienti terroristici. Tali gruppi erano particolarmente forti in Veneto, ove trovavano appoggio nelle locali basi Nato. Li coordinava il colonnello Amos Spiazzi, condannato per il tentativo golpista “Rosa dei venti” ma egualmente promosso generale. Nella sua villa alla periferia di Verona campeggiava una enorme ascia bipenne, simbolo di Ordine nuovo. All’indomani della strage di Bologna fu a lui che i servizi affidarono il compito di “bruciare” ogni possibile traccia che potesse portare a scoprire i rapporti tra gli attentatori e la “struttura occulta”, ai vertici della quale si era ormai insediato Licio Gelli.
A fare da collante dell’intera rete erano i Nuclei per la difesa dello Stato (NdS), di fatto appendice della organizzazione Gladio, struttura paramilitare voluta dal Pentagono (che la battezzò “Stay Behind”, rimanere alle spalle) e rimasta in gran parte segreta. I Nuclei erano guidati da ufficiali, avevano libero accesso alle caserme e agli arsenali, accoglievano militari e civili. Rispetto a Gladio però gli Nds addestravano anche personaggi notoriamente legati ad ambienti terroristici. Tali gruppi erano particolarmente forti in Veneto, ove trovavano appoggio nelle locali basi Nato. Li coordinava il colonnello Amos Spiazzi, condannato per il tentativo golpista “Rosa dei venti” ma egualmente promosso generale. Nella sua villa alla periferia di Verona campeggiava una enorme ascia bipenne, simbolo di Ordine nuovo. All’indomani della strage di Bologna fu a lui che i servizi affidarono il compito di “bruciare” ogni possibile traccia che potesse portare a scoprire i rapporti tra gli attentatori e la “struttura occulta”, ai vertici della quale si era ormai insediato Licio Gelli.

ll professor Aldo Giannuli, consulente della Procura generale di Bologna, per conto dei magistrati ha individuato due distinte fasi nello sviluppo dell’attacco reazionario alle libertà costituzionali. La prima, databile sino al 1974, durante la quale la rete eversiva operò con l’intento di giungere a rovesciare il sistema anche con la violenza, i colpi di stato, i pronunciamenti militari. Sono di quell’epoca i massacri compiuti della polizia ai danni dei lavoratori in lotta per la democrazia nelle piazze italiane (Modena, Genova e Reggio Emilia sopra tutte), il piano golpista progettato dai Carabinieri di De Lorenzo, e poi la lunga serie di sanguinosi attentati eseguiti prima di giungere alla strage di Piazza Fontana, a Milano. Dopo l’eccidio alla Banca dell’Agricoltura, che si abbattè su un’Italia attonita e in gran parte ancora inconsapevole, il colpo di maglio sulle istituzioni avrebbe dovuto venire dallo stato di emergenza e dalle leggi eccezionali richieste a gran voce dal Msi di Giorgio Almirante, che il governo del democristiano Mariano Rumor rifiutò però di assecondare. Per questo Ordine nuovo condannò a mort
e il primo ministro, e tentò effettivamente di eseguire la condanna anni dopo, nel 1973, con la bomba scagliata da Gianfranco Bertoli (il suo nome era negli elenchi di Gladio) davanti alla questura di Milano. Rumor rimase illeso ma l’ordigno uccise quattro cittadini.

Piazza Fontana, coi suoi 17 morti ancora impuniti (mentre ai parenti delle vittime è stato chiesto di pagare il costo dei logoranti vani processi) è il primo simbolo dei poteri acquisiti dalla “struttura occulta”, interamente impegnata nel costruire la strategia della tensione. L’Ufficio affari riservati di D’Amato lavorò per impedire l’accertamento della verità, nascondendo le informazioni sulle responsabilità delle cellule venete di Ordine nuovo e costruendo il depistaggio di una falsa pista anarchica. E appena un anno dopo, nel dicembre 1970, scattò il vero e proprio tentativo golpista operato dal collaborazionista già comandante della ex Decima Mas, Junio Valerio Borghese.
I suoi uomini, appoggiati dalle guardie forestali (ma era previsto il coinvolgimento di reparti dei Carabinieri) occuparono a Roma il Viminale e gli studi Rai; centinaia di armati stazionarono nelle vie d’accesso alla capitale presidiando i centri di comunicazione. Era pronto il piano di penetrazione al Quirinale ove Licio Gelli (secondo le carte raccolte dal giornalista Carmine Pecorelli) avrebbe dovuto arrestare il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, obbligandolo a leggere un comunicato radiofonico rivolto al Paese per annunciare l’insediamento di un governo autoritario. Alla mafia era stato affidato il compito di assassinare il capo della Polizia Angelo Vicari, e squadre di elementi armati avrebbero rastrellato Roma e altre città per arrestare i più noti esponenti dei partiti di sinistra. Il giornalista fascista Guido Giannettini confessò poi che il rapporto diretto con Borghese fu mantenuto, in quel periodo, dal capo dell’Uar Federico Umberto D’Amato.

Ore drammatiche, ma tutto si fermò perché —come risulta dalle ricerche condotte dal giudice di Milano Guido Salvini — i più alti vertici delle forze armate e dei Carabinieri in realtà si opposero ad un golpe guidato dal fascista Borghese. Molto di più non è possibile documentare, perché il presidente del consiglio Giulio Andreotti provvide subito ad epurare le liste dei golpisti di tutti i nomi dei politici, dei finanziatori e degli ufficiali superiori coinvolti, in particolare quelli collegati alla Nato e a Gladio. Scomparve anche il nome di Licio Gelli, che il generale Gianadelio Maletti definì “sacro” per il servizio segreto.
In ogni caso il colpo di stato fallì perché il governo degli Stati Uniti rifiutò di avallare l’operazione. Gli americani avevano iniziato a valutare un mutamento di indirizzo, per il quale negli anni successivi (e dopo la caduta di Nixon travolto dall’affare Watergate) lasciarono cadere, uno dopo l’altro, i regimi fascisti della Grecia, della Spagna e del Portogallo, e iniziarono a percorrere la via che avrebbe portato ai primi tentativi di distensione con l’Unione Sovietica, almeno in Europa.
In casa nostra, però, la “struttura occulta” rifiutò ogni ipotesi di distensione, decisa a continuare a fronteggiare anche con la violenza la crescente forza politica ed elettorale del Pci e delle sinistre. Nelle fabbriche era stato conquistato lo Statuto dei diritti dei lavoratori (legge 300 del 1970), nella società nuovi spazi di democrazia si aprirono, con le conquiste anche sui diritti alla salute, nel mondo della scuola e tra le masse femminili, sino a giungere nel 1974 al vittorioso referendum sul divorzio che sancì i sostanziali cambiamenti intervenuti nel Paese.

La contrapposizione degli ambienti nostrani più reazionari trovò linfa nelle linee sostenute dagli ambienti del Pentagono, trincerati dietro l’oltranzista generale William Westmoreland, reduce dai massacri indiscriminati compiuti in Vietnam. Costui già nel 1970 aveva redatto un “manuale” segretamente distribuito ai governi amici, secondo il quale gli Stati Uniti escludevano ormai interventi armati nei Paesi alleati, ma ritenevano lecite azioni violente per stroncare i movimenti popolari, senza rinunciare a spargere il terrore con attentati sanguinosi da attribuire alle sinistre. Un’azione sotterranea svolta da gruppi coi quali anche uomini delle basi americane avrebbero potuto collaborare, seppure strettamente in incognito.
A Roma il “manuale” fu letto ma subito secretato dai nostri politici, consapevoli che la sua diffusione avrebbe minato i rapporti tra Italia e Stati Uniti. A considerarlo come vera e propria linea di azione, e a servirsene come alibi — hanno sottolineato il professor Giannuli e i giudici di Bologna — fu invece l’ambiente raccolto attorno a Gelli. Che dopo il fallimento di Borghese volle comunque dare il via ad una intensificazione della campagna terroristica, durante la quale fu lasciata mano libera ai fascisti e neonazisti di Ordine nuovo, guidati in Veneto da Carlo Maria Maggi, già coinvolto nell’attentato di Piazza Fontana. Al suo fianco esponenti delle ideologie più estreme, come Fachini, Zorzi, Digilio, Rognoni, Gilberto Cavallini; strettamente collegati a Roma con Paolo Signorelli, De Felice, Semerari, i cui insegnamenti plasmeranno i Nar, gli “spontaneisti” armati di Valerio Fioravanti.

Tutti personaggi, costoro, di cui i servizi segreti conoscevano perfettamente movimenti e progetti, anche grazie agli informatori infiltrati nei vari gruppi. Ma in nessun caso — sottolineano i giudici di Bologna — si intervenne per prevenire gli attentati. Così fu, in quei primi anni Settanta, per i moti parafascisti di Reggio Calabria, ove furono fatti deragliare con l’esplosivo due treni di lavoratori provenienti dal nord. Così fu a Brescia, dove a maggio 1974 una bomba sistemata in Piazza della Loggia uccise otto insegnanti del sindacato scuola Cgil, proprio alla vigilia del referendum sul divorzio. E ancora ai primi di agosto a San Benedetto Val di Sambro, dove sul treno Italicus fu fatto esplodere un ordigno che uccise dodici persone, pochi minuti prima che il convoglio giungesse alla stazione di Bologna.

I servizi sapevano in anticipo chi sarebbero stati gli attentatori e quando avrebbero agito, ma non li fermarono. Intervennero invece per depistare le inchieste della magistratura. A Brescia finsero di ignorare il ruolo di organizzatore sostenuto dal capo di Ordine nuovo Carlo Maria Maggi, che subito dopo l’eccidio addirittura preannunciò ai suoi il successivo attacco a Bologna. Anche dell’attentato all’Italicus il generale Maletti era stato perfettamente prevenuto, ma lasciò che il segretario missino Almirante accusasse falsamente giovani studenti comunisti. Il servizio (l’allora Sid) sapeva del resto che Licio Gelli aveva personalmente finanziato un gruppo di bombaroli fascisti toscani autori di attacchi ai treni. Al capo di costoro, Augusto Cauchi, fu consentito di rifugiarsi in Spagna da Delle Chiaie, e poi di fuggire in sud America. In quei mesi, sulla spinta delle reazioni indignate all’inerzia delle forze di polizia di fronte al terrorismo nero delle stragi, si rafforzò un terrorismo di segno opposto, quello delle Brigate rosse, alimentato da operai e studenti. I servizi segreti lo avevano previsto, e volutamente non lo avevano impedito: anzi si adoperarono per infiltrare propri agenti nei nuovi gruppi, al fine di servirsi anche di questi al momento opportuno.

Nessun governo di quegli anni osò affrontare il crescente potere criminale e la palese propensione eversiva della loggia di Gelli. Lo fecero invece — e non sembri paradossale — i massoni americani, o almeno quelli di parte democratica, i quali intentarono un vero e proprio processo alla P2 minacciandone l’espulsione dal novero del Grande Oriente, massima espressione mondiale della “fratellanza”. Come ha spiegato la dottoressa Piera Amendola, già consulente della Commissione stragi e in questa occasione al fianco dei magistrati della Procura generale bolognese, Gelli riuscì a evitare la condanna grazie all’appoggio dei potenti massoni texani, ma fu costretto ad impegnarsi circa l’introduzione di modifiche nell’assetto della loggia. Questa non solo era dominata da vecchi fascisti e militari avventurieri, ma era divenuta anche centro pulsante di operazioni finanziarie allarmanti anche per gli Usa. Il caso Sindona, la spoliazione del Banco Ambrosiano col coinvolgimento del Vaticano e delle cosche mafiose, il riciclaggio dei capitali derivanti dal traffico di droga: tutto passava dalla P2.
Al fine di preservare il proprio potere e l’influenza sui governi di mezzo mondo (in particolare quelli guidati dai feroci colonnelli cileni e argentini) il capo della P2 dovette promettere di accettare adesioni provenienti da ambienti meno compromettenti seppure a loro volta legati alla destra (imprenditori, finanzieri pubblici e privati, giornalisti, politici). Il venerabile elaborò persino un nuovo progetto, codificato in un “memorandum” che volle presentare pubblicamente come contributo alla soluzione dei problemi del Paese. Ad esso era legato un “piano di rinascita democratica”. Con esso i sodali di Gelli affermavano di rinunciare ad ipotesi golpiste; quella che si prefiggevano, ed era già in atto, era però una progressiva occupazione delle istituzioni, insediando uomini legati alla P2 nei gangli vitali della politica, dell’economia, delle Forze armate e dell’informazione. Era programmata anche la corruzione dei singoli e dei partiti al governo, dei sindacati e della magistratura. Dal canto suo Gelli aveva iniziato la scalata al Banco Ambrosiano e al “Corriere della Sera”.

Soltanto Aldo Moro ebbe la forza di reagire all’ inquinamento politico e morale in cui precipitò l’Italia, accettando di confrontarsi col maggior partito dell’opposizione, e di dare vita col Pci di Enrico Berlinguer a intese di governo capaci di rispondere alle attese delle grandi masse popolari. Le Brigate rosse (qualcuno ritiene aiutate da agenti esterni) provvidero a stroncare la possibile svolta assassinando il presidente democristiano, e gettando il suo partito nella più grave crisi del dopoguerra. In quella difficile fase — come ha ricostruito la dottoressa Amendola — i circoli oltranzisti americani temettero che in Italia i comunisti avrebbero potuto impossessarsi del potere. E fu Licio Gelli a tranquillizzarli, richiamando al lavoro i gruppi terroristici apparentemente “in sonno”, gli stessi che pochi anni prima avevano vissuto come un tradimento il pur timido tentativo da parte dei governi, come quello Rumor, e di giudici coraggiosi, tra i quali Vittorio Occorsio (assassinato per questo dal neofascista Pier Luigi Concutelli) di smantellare i gruppi eversivi più rappresentativi, Ordine nuovo e Avanguardia nazionale.

Con qualche elemento di novità, però. La Corte di Assise di Bologna ha ascoltato in aula numerosi testimoni a suo tempo direttamente coinvolti nella strategia della tensione: ex terroristi, i quali hanno descritto come nella seconda metà degli anni Settanta l’estrema destra cercò di coinvolgere nelle attività eversive generazioni più giovani di fascisti. Le organizzazioni dei “tramoni”, come vennero definite, rimasero nell’ombra, mentre si affermarono nuove sigle sotto le quali si aggregarono piccoli gruppi armati, composti per lo più da ragazzi affascinati dalla efficienza mostrata dalle Br in via Fani. Sigle nominalmente differenti (“l’arcipelago” di cui, prima di essere brutalmente assassinato, aveva parlato anche Sergio Calore) accomunate però dalle stesse furiose motivazioni antiistituzionali, per le quali furono realizzati numerosi tragici attentati anche contro la magistratura, i giornalisti e le forze dell’ordine.

Formazioni come Lotta di popolo, Terza posizione e Nuclei armati rivoluzionari (Nar), ben insediate a Roma e nel Veneto, non disdegnavano ora di accogliere al proprio interno appartenenti a bande criminali, qualcuno sostenitore di posizioni ideologiche di diversa natura: anticapitalista, antimperialista e persino della estrema sinistra marxista, per cercarne collaborazioni operative. Nulla di nuovo, in realtà, se si pensa che in passato analoghe intese erano state caldeggiate da personaggi come Franco Freda (responsabile della strage di Piazza Fontana) e Mario Tuti, seguace di Borghese. Ma i nuovi gruppi amavano autodefinirsi “spontaneisti”; una immagine di purezza rivoluzionaria cui il capo dei Nar, Valerio Fioravanti, si è falsamente ammantato all’indomani della strage del due agosto, e che ancora oggi gli vale da scudo protettivo nei confronti di tanta parte della pubblica opinione.
La Procura generale di Bologna ha accertato invece che nel triennio dal 1978 al 1981 gli “spontaneisti” di Fioravanti eseguirono più di cento tra rapine, attentati e omicidi di avversari e poliziotti. In primo luogo l’assassinio a Roma del magistrato Mario Amato: ovvero colui che nell’indifferenza ostile della sua Procura, aveva colto e investigato i rapporti inconfessati dei neofascisti e in particolare dei Nar con la banda della Magliana e con esponenti della massoneria, oltreché dei servizi segreti. Prima di essere ucciso il giudice Amato aveva voluto lanciare un allarme esplicito: “siamo alla vigilia di una guerra civile”, aveva detto ai colleghi del Csm. La esecuzione della sua condanna a morte precedette di quaranta giorni la strage di Bologna.

La Corte di assise ha ricostruito per intero i movimenti dei Nar dopo il delitto di Amato. Fioravanti si rifugiò sul mare di Tre Fontane nel trapanese — il regno del futuro capo dei capi Matteo Messina Denaro — dove perfezionò il progetto della strage alla stazione. Il padrone di casa, Francesco Ciccio Mangiameli, presente ai decisivi colloqui intervenuti tra Nar, massoni e mafiosi, all’indomani del due agosto confesserà tutto ad un inviato del Sisde, il colonnello Amos Spiazzi, il quale, con una intervista al settimanale l’Espresso, suggerirà di fatto a Fioravanti l’opportunità di eliminare il pericoloso testimone. Nel frattempo, il 30 luglio, Fioravanti e la sua compagna Francesca Mambro raggiunsero Roma.
Nella capitale erano presenti anche Licio Gelli e il suo operatore finanziario Mario Ceruti. Quello stesso giorno, come ha giudicato la Corte di assise, i Nar ricevettero un congruo anticipo (un milione di dollari in contanti) sulla somma di cinque milioni che era stata promessa agli attentatori. Lo attestano appunti redatti dallo stesso Gelli, ritrovati negli uffici di Castiglion Fibocchi. Il denaro fu contabilizzato insieme ai pagamenti destinati ad altri soggetti coinvolti a salvaguardia dell’operazione — in tutto quindici milioni di dollari — in un documento finale denominato “Bologna”, sequestrato a Ginevra nelle tasche del “venerabile”. Da Roma Fioravanti e la Mambro volarono poi a Venezia, dove Gilberto Cavallini li ospitò a Treviso: con lui, e con Luigi Ciavardini, due giorni dopo arrivarono a Bologna.
 Compiuta la strage i Nar di Fioravanti (egli stesso insieme a Mambro, Cavallini, Vale) si separarono, e si rifugiarono in appartamenti gestiti da società del Sismi e del Sisde, le rinnovate sigle dei servizi segreti militare e civile. A Roma, in via Gradoli, i terroristi neri avevano potuto affittare sotto falso nome ben due locali, uno dei quali era il medesimo appartamento dal quale le Brigate rosse di Mario Moretti avevano gestito la estenuante tragica vicenda del sequestro Moro. A Milano, in via Washington, i Nar si sistemarono nel palazzo ove i servizi tenevano la centrale di ascolto delle comunicazioni militari, anche Nato, e dove operava il capo del cosiddetto “Anello”, un gruppo di agenti addetti alle operazioni più sporche non ancora del tutto chiarite. Tra queste i misteriosi omicidi di persone scomode per il potere, spesso mascherati da suicidi o incidenti stradali, la fuga del criminale nazista Kappler e la trattativa per il rilascio dell’assessore campano Ciro Cirillo sequestrato dalle Br.
Compiuta la strage i Nar di Fioravanti (egli stesso insieme a Mambro, Cavallini, Vale) si separarono, e si rifugiarono in appartamenti gestiti da società del Sismi e del Sisde, le rinnovate sigle dei servizi segreti militare e civile. A Roma, in via Gradoli, i terroristi neri avevano potuto affittare sotto falso nome ben due locali, uno dei quali era il medesimo appartamento dal quale le Brigate rosse di Mario Moretti avevano gestito la estenuante tragica vicenda del sequestro Moro. A Milano, in via Washington, i Nar si sistemarono nel palazzo ove i servizi tenevano la centrale di ascolto delle comunicazioni militari, anche Nato, e dove operava il capo del cosiddetto “Anello”, un gruppo di agenti addetti alle operazioni più sporche non ancora del tutto chiarite. Tra queste i misteriosi omicidi di persone scomode per il potere, spesso mascherati da suicidi o incidenti stradali, la fuga del criminale nazista Kappler e la trattativa per il rilascio dell’assessore campano Ciro Cirillo sequestrato dalle Br.
La torbida vicenda Cirillo, connessa alla spartizione dei colossali finanziamenti per la ricostruzione dopo il terremoto del 1980 a Napoli e in Irpinia, fu gestita dall’Anello e dal Servizio segreto militare Sismi fianco a fianco con il boss camorrista Raffaele Cutolo. A facilitare gli incontri tra i malavitosi e i servizi segreti fu il magistrato Ugo Sisti, da poco direttore dell’amministrazione penitenziaria. Sino al settembre 1980 egli era stato a capo della Procura della Repubblica di Bologna. Recenti indagini ne hanno svelato gli stretti rapporti mantenuti con gli ufficiali del Sismi più coinvolti nelle trame piduiste, che furono liberi di attuare i più eclatanti depistaggi a protezione di chi aveva ordinato e collocato la bomba.

Da parte sua, il giorno dopo l’eccidio alla stazione, anziché guidare i propri sostituti alla ricerca degli attentatori, il dottor Sisti aveva abbandonato la scorta per recarsi a riposare (così sostenne) in un albergo sulle colline reggiane, la Mucciatella, di proprietà dell’amico fascista Aldo Bellini, vicino agli ambienti di Ordine nuovo e del suo stesso leader Carlo Maria Maggi. La mattina del giorno dopo, 4 agosto, alla Mucciatella giunsero anche gli agenti dell’Ucigos, impegnati in perquisizioni alla ricerca dei possibili autori dell’attentato. L’avanguardista Paolo Bellini, uno dei figli dell’albergatore, risultava infatti latitante ricercato, ed era inserito negli elenchi dell’estrema destra neofascista. Agli agenti sbigottiti il capo della Procura bolognese si presentò senza spiegare nulla; si complimentò per il loro lavoro, e si allontanò in auto con l’amico Aldo. Soltanto dopo anni la polizia stese un rapporto sullo stupefacente soggiorno di Sisti a casa Bellini; e il magistrato si giustificò sostenendo di non aver saputo che il figlio del suo ospite fosse un pericoloso ricercato.

Fuggito in Brasile nel 1977 dopo il tentato omicidio di un fidanzato della sorella, Paolo Bellini era rientrato in Italia nel 1978 sotto il falso nome di Da Silva, e sfruttando l’amicizia paterna con importanti esponenti del Movimento sociale (tra cui il senatore reggiano Franco Mariani, difensore di Almirante e Delle Chiaie) si era sistemato a Foligno per acquisire il brevetto di pilota d’aereo. A Foligno Bellini contrasse stretta amicizia con un collaboratore di studio dell’avvocato senatore Stefano Menicacci, altro più noto e storico legale di Delle Chiaie. Menicacci ha tuttavia smentito di avere mai incontrato il falso Da Silva. Risulta che il magistrato Ugo Sisti abbia volato invece più volte col sedicente pilota brasiliano, ma sostenne poi di non avere mai riconosciuto in lui il figliolo latitante dell’amico Aldo.

La Procura generale di Bologna ha accertato che l’intera carriera criminale di Paolo Bellini fu accompagnata delle protezioni dei servizi segreti. A cominciare dal depistaggio a suo favore dopo l’assassinio del giovane Alceste Campanile, militante di Lotta continua, eseguito nel 1975 da Bellini su ordine degli avanguardisti toscani che intendevano provocare tensioni in un periodo elettorale. Già poche ore dopo l’omicidio l’allora servizio Sid diramò alle questure fonogrammi coi quali si attribuiva il delitto ad elementi brigatisti; al padre della vittima fu inoltre fatta leggere una falsa informativa che accusava magistrati e intellettuali reggiani vicini al Pci. Negli anni successivi i servizi negarono di possedere notizie sui movimenti di Bellini. Con un falso passaporto fornitogli da Avanguardia, egli era volato in Brasile, Argentina, Venezuela e Paraguay: Paesi dove l’avanguardista reggiano si collegò coi fuoriusciti fascisti, col golpista Gaetano Orlando e con Elio Massagrande, tra i maggiori esponenti dell’eversione ordinovista, il quale nella cui azienda di Asunciòn fu ospitato anche Licio Gelli, all’epoca latitante dopo il crac del Banco Ambrosiano. Il passaporto utilizzato da Bellini apparteneva proprio a Massagrande.

Tornato in Italia Bellini si avvalse dell’omertà da parte di coloro che ne conoscevano la reale identità, tra i quali due sacerdoti che addirittura ne celebrarono nuove nozze sotto falso nome. Persino le sue impronte digitali erano scomparse dagli uffici del distretto militare. Ma alla fine fu arrestato in Toscana per un traffico di mobili rubati, e due altri detenuti lo riconobbero. Soltanto allora il Sisde finì per ammettere che il falso Da Silva era in realtà Bellini. I compagni di carcere cercarono di trarre profitto dalle notizie che circolavano nel penitenziario di Reggio, e riferirono al magistrato una confidenza rilasciata ad uno di loro dal fratello di Bellini, Guido, scomparso pochi mesi dopo: ovvero che la mattina del due agosto Paolo era stato alla stazione di Bologna insieme ad importanti esponenti dell’eversione fascista, Delle Chiaie, Massagrande, Gaetano Orlando e un tedesco. Paolo aveva portato a Bologna l’esplosivo prelevato in Toscana, e per la partecipazione all’attentato era stato ricompensato con cento milioni di lire. La citazione di Massagrande, Delle Chiaie e Orlando, personaggi di tanto rilievo, sembrò ai primi inquirenti frutto di pura fantasia. Si chiarì poi che in effetti Guido Bellini sapeva come essi fossero davvero in contatto col fratello, e che egli stesso li aveva frequentati in sud America. Ciò attribuiva indubbio peso alle confidenze riferite dai tre detenuti, anche se alla presenza dei presunti complici indicati non si trovò traccia.

Indagato nei primi anni Novanta con l’accusa di aver partecipato alla strage, Paolo Bellini si avvalse di un alibi sostenuto da tutta la sua famiglia. Anche la moglie Maurizia giurò allora che la mattina del due agosto, nelle ore in cui era avvenuto l’attentato, Bellini era a Rimini ove si era ricongiunto coi parenti in vacanza, per proseguire poi verso un albergo del Tonale. L’avanguardista fu prosciolto, ma le indagini proseguirono raccogliendo nuovi elementi di accusa. Decisivo un filmato amatoriale realizzato il due agosto da un turista svizzero, Harald Polzer. Egli, di ritorno dalle vacanze riminesi, era sul treno che fu bloccato a Bologna dall’esplosione in stazione. Girò alcune sequenze con la propria camera Superotto, e in una di queste appare, proprio sul primo binario, un giovane baffuto che cammina tra la gente ferita e in fuga. Gli esperti della polizia che hanno visionato le immagini (ritrovate negli archivi del tribunale grazie all’avvocato Andrea Speranzoni, uno dei legali della Associazione tra i familiari delle vittime) hanno identificato in quel giovane le fattezze di Bellini; e anche la moglie, dopo diverse titubanze, ha infine riconosciuto con certezza il marito sul luogo della strage.
La signora ha ammesso che l’alibi raccontato trent’anni prima era stato precostituito dal suocero Aldo, incontrastato e violento sovrano della famiglia Bellini, il quale aveva imposto alla nuora di mentire. Secondo i nuovi orari ricostruiti dalla signora, l’avanguardista aveva potuto tranquillamente partire in auto da Reggio Emilia di primo mattino, fermarsi a Bologna per assecondare i complici di Nar e Terza posizione nella esecuzione dell’attentato, e poi ripartire in direzione di Rimini dove in effetti giunse tra le ore 13 e le 14, quando già i famigliari aveva pranzato.

L’imputato ha negato con forza, i suoi difensori hanno a lungo disputato su sdettagli di quei fotogrammi, ma gli esperti incaricati dalla Procura generale non hanno avuto dubbi. E neppure i giudici della Corte di assise, che hanno inflitto a Bellini, sia pure in primo grado, la condanna all’ergastolo; questo dopo un processo dal quale è emerso tra l’altro che l’avanguardista reggiano era ben conosciuto e protetto anche dai Nar di Gilberto Cavallini, il quale aveva appuntato il suo nome in un elenco di camerati da aiutare in carcere.
Gli inquirenti hanno indagato a lungo sul passato e sul presente dell’avanguardista reggiano il quale, offrendosi quale collaboratore di giustizia, è riuscito ad ottenere non pochi benefici. È rimasto sempre in libertà nonostante abbia dovuto confessare l’assassinio di Alceste Campanile (ma quando ormai era prescritto), aggregandosi nel frattempo alle famiglie della ’ndrangheta calabrese all’assalto della ricca Emilia. Alla guerra per il predominio dei gruppi criminali Bellini ha contribuito agendo come un freddo killer, eseguendo dieci omicidi tra Reggio Emilia e la Calabria, tutti tranquillamente confessati. Nonostante ciò, e sempre sotto lo scudo del collaboratore, l’avanguardista ha potuto muoversi per l’Italia a proprio piacimento: sino a proporsi ai Carabinieri come interlocutore della mafia in quella che è stata definita la “trattativa” tra lo Stato e i vertici delle cosche, reduci dalle stragi di Falcone e Borsellino, e in procinto di ricattare le istituzioni con i sanguinosi attentati del 1993 ai beni artistici del Paese.

Sarebbe stato Bellini a suggerire al boss Antonino Gioè l’idea di colpire i monumenti, e generare il panico diffondendo siringhe infette sulle spiagge. I magistrati di Palermo, Firenze e Roma, così come i colleghi di Bologna, sono convinti che anche a questo proposito Bellini non abbia ancora raccontato tutta la verità. Fedele all’impegno assunto ormai tanti anni fa, egli continuerebbe dunque a nascondere la complessità dei rapporti intrattenuti coi servizi segreti e con la “struttura occulta”, che anche suo tramite sarebbe entrata in una ulteriore fase criminale. Che egli ne abbia fatto parte (come gli rinfacciò Sergio Picciafuoco, un altro neofascista presente alla stazione di Bologna) sarà difficile dimostrarlo, data la condizione sgangherata in cui sono stati lasciati gli archivi del Sismi e del Sisde, nonché quelli dell’Ufficio affari riservati di D’Amato. Egli ha tuttavia ammesso in più di una circostanza che il padre Aldo e il magistrato Ugo Sisti cercarono di convincerlo ad entrare negli apparati della nostra intelligence; sostiene di avere rifiutato, ma i militanti di Avanguardia, Delle Chiaie per primo, hanno sempre negato di avere lavorato per la parte sbagliata dello Stato.

In questi ultimi tempi Paolo Bellini s’è visto revocare gli arresti domiciliari. Trasferito in carcere dopo che in intercettazioni telefoniche è stato udito ipotizzare una propria fuga in Ucraina. Ma soprattutto avrebbe pronunciato minacce di morte in direzione della ormai ex moglie, che gli ha smontato l’alibi e ora vive sotto protezione, e della famiglia del giudice Francesco Caruso, il presidente della Corte di assise che lo ha riconosciuto tra i responsabili materiali della strage del due agosto.
Roberto Scardova, già giornalista de “l’Unità” e inviato speciale del Tg3. Si è occupato dei procedimenti giudiziari sulle stragi di Piazza Fontana, Brescia, Italicus, Bologna, e ha seguito le lunghe indagini sulla tragedia di Ustica. Tra i suoi reportage, ricordiamo quelli sull’incidente nucleare di Chernobyl, sulle stragi nazifasciste di Marzabotto e di Sant’Anna di Stazzema, sulla guerra in Afghanistan, sul mancato accertamento della verità dell’assassinio in Somalia di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. È autore di numerosi libri, tra cui, per Castelvecchi editore, “L’Oro di Gelli” e “Italicus. 1974, l’anno delle quattro stragi”
Pubblicato mercoledì 2 Agosto 2023
Stampato il 13/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/finestre/stazione-di-bologna-la-storia-nascosta-ditalia/