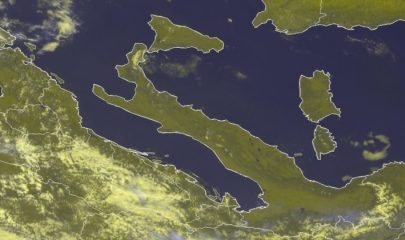Con questo articolo si conclude la breve ma compiuta ricerca sulle origini storico-filosofiche del razzismo che abbiamo chiesto al giovane studioso napoletano Andrea Pascale.
Con questo articolo si conclude la breve ma compiuta ricerca sulle origini storico-filosofiche del razzismo che abbiamo chiesto al giovane studioso napoletano Andrea Pascale.
Nel mondo in cui viviamo, parlare di razzismo significa affrontare una ricerca. Nulla di quello che il passato ci ha proposto vale a spiegare una sola riga del nostro presente. Questo è il sentimento che ha provato la generazione che è nata dopo la seconda guerra mondiale: un mondo nuovo non più da leggere, ma da scrivere, si dipanava di fronte ai loro occhi. Avvertiamo la stessa difficoltà, oggi, nel parlare di vecchi concetti, come il razzismo, nel nostro contesto. Ma la nostra generazione non ha subito lo shock della guerra che ha spazzato via in un istante tutto quello che fino ad allora era stato costruito, no. Noi non abbiamo avuto l’atomica, noi non abbiamo avuto Auschwitz. Viviamo nel solco della storia, nella voragine del cambiamento che si impone silenzioso, si insinua negli interstizi della vita di tutti i giorni. Oggi abbiamo bisogno di un nuovo abbecedario per leggere il mondo, la nostra Hiroshima sarà linguistica. Siamo immersi in un lago di nuove parole entro cui inserire il senso di ciò che ci interessa, del razzismo. L’obiettivo è mostrare che il razzismo non è semplicemente una parola a cui dover dare un senso nuovo, ma una pratica, disumana e necessaria al capitale, che mostra le profonde contraddizioni che segnano il nostro presente, che stridono da ogni angolo del reale come il sibilo di una sirena sotto i bombardamenti. Su queste contraddizioni si apre lo spazio del cambiamento, ma bisogna smascherarle, renderle chiare e visibili.
Ci sono tante parole a cui le nostre orecchie si sono gradualmente abituate senza fare troppe domande. Ci sono i migranti, il vessillo delle nuove invasioni barbariche di cui dobbiamo avere paura, per cui dobbiamo provare odio. Ci sono quelli che “ci rubano il lavoro” e questa nuova parola, lavoro, che sfugge ad ogni vecchia definizione.
 E poi c’è quella parola, neoliberismo, quella parola piena di inganni e promesse che tiene insieme le redini del discorso razzista. C’è neo e già sentiamo l’eco del nuovo, del superamento del vecchio, con tutto l’entusiasmo di un nuovo inizio, di una seconda possibilità. E poi abbiamo liberismo e d’istinto sentiamo il suono di libertà, di una nuova libertà che si staglia dinanzi ai nostri occhi stupiti. Più stupidi che stupiti, in effetti. Ci siamo lasciati ammaliare dal canto delle sirene, ma in questo mare non è dolce il naufragare. Come stanchi relitti, ci lasciamo trascinare sul fondo dal peso di quest’inganno.
E poi c’è quella parola, neoliberismo, quella parola piena di inganni e promesse che tiene insieme le redini del discorso razzista. C’è neo e già sentiamo l’eco del nuovo, del superamento del vecchio, con tutto l’entusiasmo di un nuovo inizio, di una seconda possibilità. E poi abbiamo liberismo e d’istinto sentiamo il suono di libertà, di una nuova libertà che si staglia dinanzi ai nostri occhi stupiti. Più stupidi che stupiti, in effetti. Ci siamo lasciati ammaliare dal canto delle sirene, ma in questo mare non è dolce il naufragare. Come stanchi relitti, ci lasciamo trascinare sul fondo dal peso di quest’inganno.
Non c’è niente di bello in questo, soprattutto, non c’è “assolutamente” niente di bello. L’inganno passa da sguardo in sguardo, fino ad affermare fieramente, l’uno all’altro, l’antico motto di Leibniz: questo è il migliore dei mondi possibili. Rapiti dalla menzogna, ci ostiniamo a portare nei nostri passi l’eco del più grande fallimento dell’uomo: lasciare che i propri binari vengano piazzati con precisione chirurgica entro le giuste barriere del neoliberismo, questa veste lucente di cui si è vestito il capitalismo contemporaneo per il suo ultimo tango. Ci lasciamo produrre come prima si producevano un paio di scarpe. Siamo un paio di scarpe che camminano solo dove il piede comanda. E se il piede ci comanda di schiacciare l’altro, noi lo facciamo, quasi con piacere, perché è questo il piacere che ci hanno insegnato a perseguire. Viviamo la finzione di un mondo libero in cui il lavoro si è fatto flessibile, non precario, dove c’è libertà di movimento, non barriere e frontiere chiuse, dove le gerarchie si fanno plastiche, non immanenti e coercitive. Eppure, basta una parola, che è una pratica come abbiamo visto, a togliere con un solo e rapido colpo di spugna tutti i veli e le menzogne che cercano di coprire la nostra prigionia. Basta vedere come il razzismo sia uno degli strumenti più funzionali per oliare gli ingranaggi della nostra presunta libertà, per smascherare le nostre catene.
 Ma le nostre catene non sono quelle che cingevano le gambe e le braccia degli schiavi nel colonialismo. Le nostre catene sono invisibili e caratterizzate da un’enorme “libertà”, purché si eserciti entro i serrati limiti a noi concessi. Le nostre catene hanno la forma dei nostri desideri, deformati e mutilati per diventare lo strumento più efficace per creare valore, per riprodurci spasmodicamente. I nostri bisogni hanno trasformato il lavoro, ma il neoliberismo ce li ha ritorti contro. Sulle nuove forme di lavoro che esprimono i naturali bisogni dell’uomo, si erge la diga del potere che non può eliminarli, perché il cuore pulsante dell’economia globalizzata vi giace, ma non può lasciarli al proprio naturale impeto, alla loro insopprimibile eccedenza, altrimenti non potrebbe valorizzare la vita, i saperi, le relazioni, le migrazioni, gli affetti. Attraverso pratiche e saperi come il razzismo, il potere, dal centro alle periferie del sociale, crea diversità ed emarginazioni, crea il negro stupratore – proprio come il Calibano di Shakespeare – e il negro agricoltore. Instilla la paura negli occhi di chi già c’è, la rassegnazione nelle mani di chi arriva, propone degradazioni razziali dopo aver imposto un certo tipo di mobilità: il Rom e l’algerino diventano minacce, non per i comportamenti dei singoli, ma per la razza che ne predetermina la criminalità, la pericolosità. Discorsi del genere corrono sulle bocche più inaspettate, perché una fitta rete di saperi e pratiche sta lavorando alla creazione di soggettività, cioè di individui, come portatori di un pensiero, di una verità.
Ma le nostre catene non sono quelle che cingevano le gambe e le braccia degli schiavi nel colonialismo. Le nostre catene sono invisibili e caratterizzate da un’enorme “libertà”, purché si eserciti entro i serrati limiti a noi concessi. Le nostre catene hanno la forma dei nostri desideri, deformati e mutilati per diventare lo strumento più efficace per creare valore, per riprodurci spasmodicamente. I nostri bisogni hanno trasformato il lavoro, ma il neoliberismo ce li ha ritorti contro. Sulle nuove forme di lavoro che esprimono i naturali bisogni dell’uomo, si erge la diga del potere che non può eliminarli, perché il cuore pulsante dell’economia globalizzata vi giace, ma non può lasciarli al proprio naturale impeto, alla loro insopprimibile eccedenza, altrimenti non potrebbe valorizzare la vita, i saperi, le relazioni, le migrazioni, gli affetti. Attraverso pratiche e saperi come il razzismo, il potere, dal centro alle periferie del sociale, crea diversità ed emarginazioni, crea il negro stupratore – proprio come il Calibano di Shakespeare – e il negro agricoltore. Instilla la paura negli occhi di chi già c’è, la rassegnazione nelle mani di chi arriva, propone degradazioni razziali dopo aver imposto un certo tipo di mobilità: il Rom e l’algerino diventano minacce, non per i comportamenti dei singoli, ma per la razza che ne predetermina la criminalità, la pericolosità. Discorsi del genere corrono sulle bocche più inaspettate, perché una fitta rete di saperi e pratiche sta lavorando alla creazione di soggettività, cioè di individui, come portatori di un pensiero, di una verità.
Esistono pensieri accettabili come la possibilità di lasciar affogare bambini a poche miglia dalla costa, perché vengono ad essere legali, e pertanto accettati, i divieti posti alla sovversione di questi discorsi, come i tentativi di salvataggio e di prima accoglienza. Esistono pensieri tollerati, come il desiderio di dar fuoco ai campi Rom, di targhettizzare, classificare un modo di vita differente, come una diversità pericolosa e inaccettabile; si possono perfino giustificare, anche parzialmente, verità e discorsi violenti e irrazionali che navigano sulle putride acque dell’indifferenza, del lassez faire e della tacita accettazione. Il potere agisce silenzioso e profondo: ogni differenza è negata, l’omologazione, l’identità sono le uniche vie percorribili per il potere.
Sono, a tal proposito, chiarissime le parole di Gilles Deleuze: “La lotta per una soggettività moderna passa attraverso la resistenza alle due forme attuali di assoggettamento, l’una che consiste nell’individuarci in base alle esigenza di potere, l’altra che consiste nel fissare ogni individuo a un’identità saputa e conosciuta, determinata una volta per tutte. La lotta per la soggettività si manifesta allora come diritto alla differenza e come diritto alla variazione, alla metamorfosi”.[¹]

Il razzismo, inoltre, è una vera e propria contraddizione che mette in luce le sinistre meccaniche di controllo che il potere esercita sui flussi migratori. Infatti, il razzismo mostra in maniera lampante come le pratiche neoliberiste agiscano per rubare vita dalle soggettività, imbrigliando i corpi in cerniere claustrofobiche, anfratti bui in cui soggiogare i desideri e gli affetti, campi di prigionia entro cui riprodurre individui, modelli di vita definiti da discorsi e pratiche di verità da armento, per addomesticare e ammansire i corpi. Il razzismo rappresenta una contraddizione con il processo di mobilitazione imposto dal mercato globale: le fabbriche si delocalizzano nei terzi mondi dove le imposte fiscali, il costo e le tutele della forza-lavoro ne favoriscono l’insediamento, la forza lavoro viene spostata da un capo all’altro del globo per le esigenze del capitale: tutto questo stride terribilmente con le barriere imposte ai flussi di migrazione. Questa assurda contraddizione deve, tuttavia, rimanere nel sistema, perché permette la creazione di un diversivo, un nemico fonte di risentimento e concentrazione della rabbia. Smascherare il doppio volto del potere è passaggio fondamentale per scagliare la giusta rabbia contro tutto ciò che mutila la vita.
Non bisogna dimenticare che “la verità è di questo mondo; essa vi è prodotta grazie a molteplici costrizioni. E vi detiene effetti obbligati di potere. Ogni società ha il suo regime di verità, la sua ‘politica generale’ della verità: i tipi di discorsi cioè che accoglie e fa funzionare come veri; i meccanismi e le istanze che permettono di distinguere gli enunciati veri o falsi, il modo in cui si sanzionano gli uni e gli altri; le tecniche e i procedimenti che sono valorizzati per arrivare alla verità; lo statuto di coloro che hanno l’incarico di designare quel che funziona come vero”.[²]
Il razzismo deve essere il nostro nemico giurato, e solo disvelando le mille e più mistificazioni, solo mostrando le contraddizioni di cui vive il potere, solo scontrandosi con le mille teste dell’Idra, portando alla luce le meccaniche di sfruttamento con cui questa solo può agire, è possibile cercare un orizzonte altro dietro la nebbia. Per trovare qualcosa di buono per cui lottare.
Forse, però, prima di una nuova etica, abbiamo bisogno di una nuova estetica. Prima di trovare un nuovo buono, dobbiamo trovare un nuovo bello, un bello per cui valga la pena compiere quel passo nuovo verso un nuovo ethos, da opporre a questi mores senza vergogna. C’è davvero bisogno di un’immagine che riempia i nostri occhi spenti, di entusiasmo e fremito. Abbiamo bisogno di qualcosa di bello, come un abbraccio, come un nuovo legame con ciò che fino ad ora è stato solo diverso. Una nuova unione con l’altro, con la nostra irriducibile differenza. Questo è bello, un colpo di spugna al razzismo, come pratica di liberazione, come nuovo orizzonte da costruire insieme. Solo da qualcosa di bello può nascere qualcosa di buono e qui, allora, restiamo in attesa, in attesa di un nuovo, in attesa di un altro, in attesa del bello.
Andrea Pascale
Note:
¹ G. Deleuze, Foucault, pg 140.
² M. Foucault, La microfisica del potere, pg 25.
Pubblicato venerdì 7 Dicembre 2018
Stampato il 19/04/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/la-falsa-verita-del-razzismo/