
Non mi definisco un poeta perché è una parola che non mi piace. Sono un trapezista. Bob Dylan, 1965
Non si può dire che Dylan manchi di originalità e neanche di una certa irriverenza. Ma è anche vero che questa definizione di sé spiega bene la sua lunga storia di artista, perennemente in bilico tra le funi di un ideale trapezio da cui lanciarsi in esibizioni spesso rischiose, quasi mai tentate prima. Un acrobata, pronto a cambiare punto d’appoggio, volteggiare nell’aria, spingersi in salti mortali e a tornare in terra, di tanto in tanto, all’occorrenza.
Diversa la definizione, più tangibile, che ne danno i critici e i biografi: “Dylan – scrive Howard Sones – è una star dell’industria discografica, uno straordinario interprete dal vivo, un simbolo della cultura popolare e, soprattutto, è il maggiore autore di canzoni del suo tempo” [Sones, Bob Dylan, p. 7]. Canzoni che, come scrive Mike Marqusee: “sorgono dalla loro era e parlano alla nostra” diventando eterne [Marqusee, Wicked Messenger, p. 55].
La popolarità di Dylan, infatti, non è dovuta a ragioni commerciali: una miriade di autori hanno venduto molti più dischi di lui. Poco importa, però, quante persone acquistino un prodotto, conta cosa quel prodotto rappresenti per loro, quale peso assuma nelle loro vite, nel dare forma e forza e un immaginario. È questo permanere a imprimere il marchio dell’eternità.
E Dylan ha scritto un tale numero di testi, raccontando storie, evocando temi tra i più disparati, da creare un campionario di immagini, simboli, mitologie, tanto corposo quanto le trame di un romanzo antropologico (e non è un caso che gli sia stato assegnato un Nobel per la letteratura). Non solo. Negli anni Sessanta il suo contributo alla musica leggera è stato travolgente: è lui ad aver ridefinito il ruolo della canzone, strumento fino a quel momento poco sfruttato a scopo comunicativo, se non da un pugno di artisti, assegnandogli qualità narrativa.
Eppure riordinare i tasselli dell’universo creativo di Dylan risulta quasi impossibile per la natura sfuggente che lo pervade. È stato uno dei simboli della controcultura: le sue canzoni sono diventate dei manifesti perché sono state capaci di polarizzare lo spirito di un’epoca, di radunare chi combatteva una stessa battaglia. Ma lui non si è mai occupato direttamente di politica.
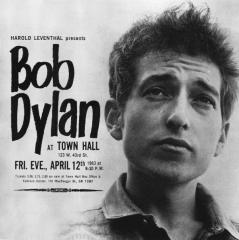
La sua personalità e le canzoni sono stati indagate secondo varie prospettive, da quella storica a quella musicologica a quella psicanalitica. Ma Dylan è multiforme, inafferrabile nelle sue molteplici facce. Quanti Dylan esistono? “Dylan impegnato, Dylan acustico, Dylan elettrico, Dylan psichedelico, Dylan esegeta biblico, Dylan cantante country, Dylan innamorato, Dylan cinico, Dylan ebreo, Dylan cristiano, Dylan rivoluzionario, Dylan tradizionalista, Dylan sereno, Dylan apocalittico”, scrive Alessandro Carrera in La voce di Bob Dylan E ognuno sembra avere una storia a sé.
Unica certezza è che nelle sue canzoni c’è la vita di un uomo: le sue passioni amorose, le inquietudini, i dubbi, le angosce, la rabbia, la fede. La storia di un individuo che è mille, centomila individui. Di chi ha amato e ha sofferto, di chi ha trovato un amore e di chi lo ha lasciato, di chi ha combattuto per un ideale, per una vita migliore, per un lavoro dignitoso, per l’uguaglianza, per la pace nel mondo. Di chi ha guardato a chi stava peggio e a chi stava meglio e ne ha tratto conclusioni. Di chi si è chiesto: chi è Dio? Le sue canzoni sono lo specchio di Svoboda che nella meravigliosa messa in scena di Traviata si alza, riflette gli spettatori e li porta in scena, a partecipare della morte di Violetta. Le canzoni di Dylan sono questo lucido e immenso specchio: costringono a prendere atto, a farsi domande, a intervenire.
E poi c’è lui, con le pieghe insolite che hanno dato forma a una vita straordinaria. Figlio di Abe Zimmerman, a sua volta figlio di immigrati ebrei dell’Europa dell’Est, e di Beatrice Stone, di famiglia ebrea di Hibbing, città della Iron Range. Quando, il 24 maggio 1941 presso il St. Mary’s Hospital alla coppia nasce questo figlio, il bambino viene registrato e circonciso. Riceverà il nome ebraico Shabtai Zisel ben Avraham, che poi sarebbe diventato Robert Allen Zimmerman e poco dopo Bob o Bobby. Lo scenario è il quartiere di Central Hilliside a Duluth, abitato in gran parte da ebrei e polacchi. Il profumo dell’oceano, i suoni delle sirene dal porto, la fine della seconda guerra mondiale.
 A Hibbing, città della Iron Range l’ossido di ferro ricopre le macchine che transitano. Gli scioperi dei minatori del 1949 sono la prima esperienza diretta di gente che insieme si batte per una causa comune. Bob ha otto anni, la famiglia è abbastanza agiata, lavorano alla Micka Electric, sono persone in vista, nella loro casa ci sono mobili di qualità, perfino la moquette. Un pianoforte. Bob comincia a suonarlo molto piccolo. Presto ha l’età per il bar-mitzvah, cioè per essere responsabile della legge ebraica, la ritualità, il rispetto dei precetti. Allora, si tiene una grande festa. Ma Bob impara anche i fondamenti della Bibbia. E poi di notte ascolta le radio dell’Arkansas, di Chicago, dell’Illinois, della Louisiana. Suonano soprattutto blues, la musica popolare americana. Con un po’ di fantasia quelle canzoni si possono reinventare al pianoforte o alla chitarra acustica. “Sono felice che un certo tipo di musica mi abbia influenzato in quel momento, perché francamente non so che ne sarebbe stato di me, in caso contrario”, dirà [Sounes, p. 38]. Non smette più di suonare Bob, che al liceo si esibisce nelle convocations, le feste studentesche. Finito il liceo non c’è niente che non voglia fare se non il musicista, benché sua madre non perda occasione di dissuaderlo: “Non continuare a scrivere poesie, per favore. Va’ a scuola e fa’ qualcosa di utile. Prenditi la laurea”, gli ripete [Sounes, p. 57].
A Hibbing, città della Iron Range l’ossido di ferro ricopre le macchine che transitano. Gli scioperi dei minatori del 1949 sono la prima esperienza diretta di gente che insieme si batte per una causa comune. Bob ha otto anni, la famiglia è abbastanza agiata, lavorano alla Micka Electric, sono persone in vista, nella loro casa ci sono mobili di qualità, perfino la moquette. Un pianoforte. Bob comincia a suonarlo molto piccolo. Presto ha l’età per il bar-mitzvah, cioè per essere responsabile della legge ebraica, la ritualità, il rispetto dei precetti. Allora, si tiene una grande festa. Ma Bob impara anche i fondamenti della Bibbia. E poi di notte ascolta le radio dell’Arkansas, di Chicago, dell’Illinois, della Louisiana. Suonano soprattutto blues, la musica popolare americana. Con un po’ di fantasia quelle canzoni si possono reinventare al pianoforte o alla chitarra acustica. “Sono felice che un certo tipo di musica mi abbia influenzato in quel momento, perché francamente non so che ne sarebbe stato di me, in caso contrario”, dirà [Sounes, p. 38]. Non smette più di suonare Bob, che al liceo si esibisce nelle convocations, le feste studentesche. Finito il liceo non c’è niente che non voglia fare se non il musicista, benché sua madre non perda occasione di dissuaderlo: “Non continuare a scrivere poesie, per favore. Va’ a scuola e fa’ qualcosa di utile. Prenditi la laurea”, gli ripete [Sounes, p. 57].
All’università si iscrive al corso di studi in materie umanistiche con specializzazione in musica: University of Minnesota. Nel quartiere di Dinkytown ogni sera si suona folk. C’è appena stato uno scandalo: tangenti pagate alle case discografiche per far passare alle radio le canzoni pop. Ci sono i Weavers, gruppo vocale di Pete Seeger, nato dagli Almanac singers che, nei campus, nei piccoli locali, per le strade, ripropongono attraverso brani folk, le vicende legate alla storia americana, gli eroi, i miti. Questa musica diventa l’emblema di un mondo incontaminato, autentico, da trasferire alle nuove generazioni. Nasce la voglia di riscoprire il suono originario delle canzoni tradizionali, ritrovarne le forme più arcaiche. Si scatenano ricerche etnologiche, musicologiche che conducono musicologi, storici, etnografi, antropologi alla scoperta dei canti primitivi dei carcerati, dei contadini, dei cowboy. Tra i ricercatori ci sono John e Alan Lomax, lo stesso che poi girerà anche le campagne d’Italia, poco dopo, alla scoperta delle fonti orali, la cultura popolare e musicale del nostro Paese.
Non è tutto. Un compagno di college presterà a Bob una copia delle memorie di Woody Guthrie, Questa terra è la mia terra, racconto romanzato della vita del musicista dell’Oklahoma: la storia del suo vagabondare per l’America alla ricerca di un lavoro e di un posto in cui stare. C’è la disperazione dei derelitti, degli emarginati, degli ultimi della terra che si affannano a campare. Sono gli hobos, i vagabondi, i disoccupati dopo l’ondata di sfruttamento dei pozzi di petrolio che ha trasformato la terra in un deserto da cui si può solo scappare. Da quel momento la lingua di Bob sarà la lingua delle canzoni di Woody Guthrie, dei suoi personaggi, dell’America dei poveri cristi. Farà di tutto per conoscerlo: lo incontrerà al New Jersey Hospital, stanco e sfiancato dalla malattia – – la corea di Huntington – che lo ucciderà. Ma Woody Guthrie resta il modello a cui tendere, artefice di una canzone al servizio della comunità, di una canzone che rivendica la sua funzione di strumento di lotta sociale, civile. Scriverà canzoni come armi che parlano la lingua di chi non ha voce, canzoni per condannare le ingiustizie e le violenze, canzoni per raccontare fatti e verità. Questa terra è la mia terra, diceva Guthrie: “l’America appartiene anche a me che la canto, benché sia l’ultimo della terra”. C’è tutta la battaglia per la conquista di diritti e di una libertà che ancora appartiene solo ad alcuni. Così, canzoni come This land is your land, Pastures of plenty, Deportee che raccontano questa epopea, segneranno fortemente tutta la successiva musica e la poesia di Dylan.

La sua determinazione a fare della musica la propria vita lo porta a New York, la città delle opportunità, il posto in cui cercare la strada della propria affermazione, costi quel che costi. Al Greenwich Village, nelle coffehouses, per le strade, giovani musicisti, anche qui, suonano e cantano brani folk: il folk revival porterà questo genere nelle piazze del mondo. È il 1961 e John F. Kennedy ha appena giurato come presidente degli Stati Uniti. Al Sud dell’America, invece, si ripetono scontri sociali innescati da problemi razziali. Quando si esibisce per la prima volta esordisce così: “Ho viaggiato per tutto il paese – dice – sulle orme di Woody Guthrie”. Canterà quelle canzoni. Ma una è sua: Song to Woody, da una melodia della canzone 1913 Massacre scritta dal musicista dell’Oklahoma. Dylan si propone di raccogliere un’eredità, anche se quel modello gli sembra irraggiungibile: Hey Woody Guthrie but I know that you know/All the things that I’m saying and a many times more/I’m singing you the song but I can’t you sing enough/’Cause therÈs not many men that’ve done the things that you’ve done
Le cofeehouses in poco tempo si riempiono di giovani, di turisti capitati lì per ascoltare la musica dell’America. Il folk è la sua strada: “In quelle canzoni – dice in Biograph – c’è molta più disperazione, tristezza, trionfo, fede nel sovrannaturale, c’è molto più sentimento profondo”. E poi c’è un’altra America, un’America che vuole ritrovare i valori perduti, soffocati da jingle pubblicitari, dalle canzonette di consumo. Canzoni che raccontano il Paese con tutta la verità possibile.
Perché la musica dell’America è quella della tradizione, ma è anche quella della cronaca di fatti quotidiani: un articolo di giornale racconta la vicenda di una gita al Bear Mountain State Park, che si trasforma in una esperienza tragicomica quando il battello non riesce a contenere tutti i passeggeri. Ne uscirà Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues, canzone ironica sull’avidità e la stupidità umana. Mai più picnic in questa America del benessere: Now, I don’t care just what you do/If you wanna have a picnic, that’s up t’ you/But don’t tell me about it, I don’t wanna hear it/’Cause, see, I just lost all m’ picnic spirit/Stay in m’ kitchen, have m’ own picnic/In the bathroom.
https://www.youtube.com/watch?v=mzzAAp3io5o
Tanto per cominciare. Perché è su questo frangente che da subito si gioca l’originalità di Bob, sul fatto, cioè di saper scrivere canzoni: “Sembrava – dice Pete Seeger – che questo genio sconosciuto scrivesse ogni giorno una canzone nuova, e bella per di più. Non robetta, ma canzoni dell’accidenti” [Sounes, p. 123]. Questa e altre gli valgono, infatti, un contratto con la Columbia Records, la più grossa casa discografica degli Stati Uniti. Il suo omonimo album d’esordio si compone di country blues della tradizione riproposti con nuovi arrangiamenti e include Song to Woody, prima canzone d’autore. Di lì a poco avrebbe scritto The Death Of Emmett Till, storia vera di un quattordicenne afroamericano assassinato in Mississippi nel 1955 per aver corteggiato una commessa bianca. “Probabilmente – scrive Howard Sounes – la prima canzone di protesta di Dylan”. Una canzone che trae spunto da fatti reali, che mette a conoscenza di un evento tragico, meschino e accende un riflettore sulle questioni razziali negli stati dell’America del sud.
Then they rolled his body down a gulf amidst a bloody red rain/And they threw him in the waters wide to cease his screaming pain./The reason that they killed him there, and I’m sure it ain’t no lie,/Was just for the fun of killin’ him and to watch him slowly die (Poi rotolarono il suo corpo giù un golfo in mezzo a una pioggia rosso sangue/Ed essi lo gettarono nelle acque profonde per far cessare le sue urla di dolore./Il motivo per cui lo hanno ucciso lì, e sono sicuro che non è una menzogna /Era solo per il divertimento di ucciderlo e vederlo morire lentamente).
Arriveranno poi altre e innumerevoli canzoni di protesta, come Talkin’ John Birch Paranoid Blues (Bootleg series) sull’ossessione anticomunista esasperata dalle campagne promosse dalla società antisemita e di estrema destra, John Birch. Dylan, come solo lui sa fare, estremizza la questione: Now we all agree with Hitlers’ views/ Although he killed six million Jews/It don’t matter too much that he was a Fascist/ At least you can’t say he was a Communist (Noi approviamo tutto quel che diceva Hitler,/Anche se ha ammazzato sei milioni di ebrei;/E non me ne frega se era un fascista,/Almeno non si può dire che era comunista./Come dire, se hai preso il raffreddore/Fatti una puntura di malaria).
https://www.youtube.com/watch?v=8aD82dWOyYE
Questo è già di per sé rivoluzionario: scrivere canzoni che parlino di fatti attuali, di questioni sociali, delle discriminazioni, che utilizzino uno strumento così leggero e volatile come la canzone per lanciarlo tra la gente carico di messaggi. L’effetto sarà dirompente.
Non a caso, infatti, i suoi testi diventeranno il manifesto delle lotte per i diritti civili dei neri e della loro resistenza civile che in quel momento stavano esplodendo. Aveva cominciato Rosa Parks nel 1955, con il clamoroso gesto di sedersi su un autobus, nella parte riservata ai bianchi, rifiutandosi di lasciare il posto. Poi nel 1960 quattro studenti neri chiederanno di essere serviti a una tavola calda per bianchi, vi rimarranno seduti dando il via al movimento dei sit-in. Poi inizieranno i freedom rides (viaggi della libertà), con i quali gruppi di attivisti neri (e anche giovani bianchi) attraverseranno gli Stati del Sud dando vita a dimostrazioni contro la segregazione, per arrivare alla marcia di Washington del 1963.
In questo scenario la voce di Bob sarebbe arrivata forte e chiara con Blowin’ in the wind (1963): melodia presa in prestito dallo spiritual No more Auction Block e un testo di versi interrogativi che tutti si concludono nella vaghezza di una risposta che è nel vento. Una canzone che dal principio non piace, considerata facile, insulsa, banale, ma che in poco tempo raccoglie tante di quelle cover da portare il pezzo in cima alle classifiche di vendita. Una canzone destinata a raccontare un periodo di attesa e di cambiamenti, sospeso tra l’impazienza e la speranza del nuovo. “Ho solo 21 anni – scrive Dylan nelle note all’album – e so che ci sono state troppe guerre. Voi gente sopra i 21 anni dovreste saperlo meglio di me. Il primo modo per rispondere alle domande di questa canzone è iniziare a porsele”.
Nel 1962 Martin Luther King veniva incarcerato in Georgia mentre lo scontro per i diritti civili si faceva sempre più acceso. Missili sovietici a Cuba spingevano Kennedy a dichiarare l’assunzione di misure atte a contrastare l’aggressione cubana; Chruščëv minacciava una guerra nucleare. “Gli ascoltatori – dice Mike Marqusee – non avevano dubbi a proposito di ciò a cui Dylan si stava riferendo nel momento in cui domandava quando le palle di cannone sarebbero state messe al bando per sempre o quanto tempo sarebbe dovuto passare prima che a certa gente fosse consentito di essere libera” [Marqusee, p. 59]. Non ci sono nomi e cognomi, non ci sono riferimenti a fatti recenti, ma la canzone raccoglie lo stesso identico comune sentire e l’interpretazione converge nella denuncia dell’attuale situazione politica e il sogno di una svolta pacifista.
La lista degli artisti che interpretano questa canzone è infinita, ma la versione di Peter, Paul e Mary, con l’armonizzazione a più voci che conferisce al brano la dimensione di una preghiera collettiva, la lancia dritta nelle prime posizioni in classifica negli Stati Uniti, avviandola al successo planetario.
Se Blowin’ in the wind resta racchiusa in una bolla di indefinitezza, A Hard Rain’s a-gonna fall, si carica di immagini sconvolgenti, segni di una catastrofe imminente: oceani morti, mantelli sanguinanti, cupe foreste, tombe. Scritta sempre nel periodo della crisi dei missili a Cuba nell’ottobre del 1962, sembra evocare il terrore di una pioggia di scorie radioattive, dovuta all’esplosione di una bomba atomica. Un’apocalisse che si compie nella distruzione del pianeta.
I’ve stumbled on the side of twelve misty mountains/I’ve walked and I’ve crawled on six crooked highways/I’ve stepped in the middle of seven sad forests/I’ve been out in front of a dozen dead oceans,/I’ve been ten thousand miles in the mouth of a graveyard/And it’s a hard, and it’s a hard, it’s a hard, and it’s a hard/And it’s a hard rain’s a-gonna fall (Ho inciampato sul fianco di dodici montagne brumose/Ho camminato strisciato su sei strade tortuose/Sono andato dentro a sette cupe foreste/Sono stato davanti a una dozzina di oceani morti/Mi sono addentrato per diecimila miglia in una tomba/E una dura, una dura, una dura, una dura/Una dura pioggia cadrà).
https://www.youtube.com/watch?v=KbQlPyLfhJ0
La svolta di Bob si è compiuta: non è più la copia di Guthrie, ma “un grande autore – dice Howard Sounes –, capace di innestare un linguaggio profondo e poetico sul filone della musica popolare”. Scriverà di continuo, di getto, da questo momento in poi. Nei pub, per strada, sui tovaglioli, scriverà in preda a una vorace ispirazione, come una sete implacabile.
Nel 1962, poi, alla Corte suprema di New York cambierà nome: Robert Allen Zimmerman è adesso, ufficialmente, Bob Dylan. Ed è leggenda. Gli album si susseguono, i brani catalizzano lo spirito del tempo e ne fanno la cronaca. Tra tutti spicca Masters of war (1963, The freewheelin’ Bob Dylan) canzone antimilitarista, scritta tra il 1962-’63 ispirata dalla corsa agli armamenti della Guerra fredda ma che esploderà di significati trasportata in altri momenti storici ugualmente sfiancati da conflitti bellici, come la guerra del Vietnam e quella del Golfo. È il pregio di certe canzoni, quello di mantenere intatta la propria carica espressiva, di sopravvivere al momento storico originario e di diventare eternamente interlocutorie. Le strofe sono cariche di violenza e di un tono acceso, perché Dylan arriva a riconoscere le ragioni profonde che portano a una guerra: c’è chi da un conflitto trae profitto. Un’accusa potentissima che Dylan sbatte in faccia all’America, esercitando il diritto di esprimere la propria voce: You might say that I’m young/You might say I’m unlearned/But therÈs one thing I know/Though I’m younger than you/Even Jesus would never/Forgive what you do (Potete dire che sono giovane /Potete dire che non so niente/ Ma c’è una cosa che so/ Nonostante sia più giovane di voi/ Nemmeno Gesù perdonerebbe mai /Ciò che voi fate).
I will follow your casket/In the pale afternoon/And I’ll watch while you’re lowered/Down to your deathbed/And I’ll stand o’er your grave/’Til I’m sure that you’re dead (Seguirò il vostro feretro/ Nel pallido pomeriggio / E resterò a guardare mentre vi calano/ Nel vostro letto di morte/ E resterò a vegliare sulla vostra tomba /Finché sarò sicuro che siete morti).
Poco dopo parteciperà a una manifestazione, nel Mississippi. Organizzata dallo Student Non-Violent Coordinating Commitee ai margini di un campo di cotone per un pubblico di braccianti afroamericani, a stretto controllo di una pattuglia della polizia e di un gruppo di bianchi. Dylan canta Only a pawn in their game, (1964, The times they are a-changin’) canzone che racconta dell’assassinio di Medgar Evers, inviato sul campo dalla National Association for the Advancement of Colored people. Omicidio avvenuto poco dopo l’annuncio di Kennedy di voler istituire una nuova legislazione sui diritti civili. Della sua morte è accusato un membro del Ku Klux Klan.
La violenza razzista – canta Dylan – è il risultato di un sistema sociale e politico ingiusto costruito perché la élite bianca abbia “leggi politiche dalla sua parte/ per proteggere la sua pelle bianca” e per le fortune di politicanti corrotti: And the Negro’s name /Is used it is plain /For the politician’s gain /As he rises to fame /And the poor white remains /On the caboose of the train /But it ain’t him to blame /HÈs only a pawn in their game (Ed il nome del negro /è usato, è ovvio, /per il guadagno del politicante /per la sua scalata al potere /ed il povero bianco rimane /sull’ultimo vagone del treno, /ma non può essere incolpato:/è solo una pedina nel loro gioco).
Il 16 aprile 1963 Martin Luther King scriveva dalla sua cella di Birmingham: “È meglio andare in carcere dignitosamente che accettare la segregazione razziale umilmente” [Lettera dal carcere di Birmingham: Pellegrinaggio alla Nonviolenza]. Il 28 agosto 1963 è il giorno della marcia su Washington. Migliaia di persone si sono radunate al Lincoln Memorial per manifestare per i diritti al lavoro e alla libertà. Dylan canta When the ships come in, brano ispirato a Jenny dei Pirati di Bertold Brecht. Seconda voce: Joan Baez.
A song will lift/As the mainsail shifts/And the boat drifts on to the shoreline./And the sun will respect/Every face on the deck,/The hour that the ship comes in (Una canzone si innalzerà/Mentre la vela maestra scenderà/E la barca scivolerà verso la spiaggia. /Ed il sole rispetterà/Ogni faccia sul ponte,/l’ora in cui la nave arriverà in porto).
È una liberazione totale, piena, a cui partecipano tutti. Durante la manifestazione Martin Luther King pronuncerà il celebre discorso: “I have a dream”. E la canzone di Dylan resterà la migliore colonna sonora di quel sogno collettivo di cambiamento e di rinascita.
La questione razziale è sempre un tema caldo e ritorna nelle successive canzoni. Esplicito in The lonesome death of Hattie Carrol, cronaca di un caso giudiziario, un omicidio avvenuto quell’anno nel Maryland. Protagonista è il proprietario terriero William Zantzinger che, ubriaco, durante un ballo di beneficienza, colpisce alla testa con un bastone la cameriera Hattie Carrol perché lenta nel servizio. La donna morirà in ospedale poco dopo. Dylan racconta il divario degli stili di vita, quello del giovane, bianco e ricco proprietario terriero, che verrà condannato a solo sei mesi di carcere, e quello umile e modesto della madre Hattie, naturalmente afroamericana.
Ma i problemi dell’America non sono solo questi: la disoccupazione, la povertà, l’alcolismo. In North country blues Dylan racconta che “L’estate è finita/ La terra si sta raffreddando/ I negozi chiuderanno uno dopo l’altro./ I miei figli se ne andranno/ Non appena sono grandi abbastanza./ Be’, qui non c’è nulla che li trattenga”.
https://www.youtube.com/watch?v=8ol_W8hyHaE
E poi, il 22 novembre 1963, il presidente John F. Kennedy veniva assassinato a Dallas, gettando l’America e il mondo intero nel baratro. Il mondo intero si ritrovava oppresso da un clima di violenza irrespirabile. Necessario un cambio di rotta: sono i giovani, adesso, che devono intraprendere un cambiamento, una trasformazione radicale. La canzone The times are a-changin’, sembra proprio dare questa spinta: “There is a battle outside raging, it’ll soon shake your windows, and rattle your walls for the times they are a changing”: C’è una battaglia fuori, – canta Bob – e sta infuriando, presto scuoterà le vostre finestre, e farà tremare i vostri muri, perché i tempi stanno cambiando.
Album interamente acustico diventerà la voce della protesta dei giovani di tutto il mondo: i tempi stanno cambiando – diceva la canzone – e i figli di oggi sono pronti a rivoltarsi contro i loro stessi padri per cambiare il mondo.
E l’universalità di Dylan non è data solo dall’affrontare la varietà di problematiche che riguardano l’esistenza umana, ma anche per la capacità di raccontarla attraverso un linguaggio di volta in volta sempre più efficace. Se dal principio il folk ha veicolato un desiderio di autenticità, l’intenzione di raccontare storie vere nude e crude, con un sound acustico, adesso Dylan approda a una nuova sfida: parlare con la lingua del rock. Più energica, più dirompente. Nel 1964 registrerà Bringin il all back home con pezzi scritti con un accompagnamento rock’n roll e invece della chitarra acustica ne imbraccerà una elettrica. I puristi del folk grideranno al sacrilegio, ma lui aveva già scelto la sua nuova strada. E avrebbe avuto ragione.
C’è Mr. Tambourine Man: una canzone che evoca l’alba, che arriva a conclusione di un lungo viaggio. Un momento di isolamento, di evasione dalla realtà, proprio quando la fuga e la sua carica problematica rappresentano uno dei nuovi temi della società americana con riferimento all’uso di sostanze stupefacenti. Ma è anche fuga dal consumismo, o verso il consumismo.
It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) è uno dei testi più angoscianti: cristi color carne che brillano nel buio, il denaro che bestemmia, un presidente degli Stati Uniti nudo. Cantata anche in momenti successivi, come durante lo scandalo Watergate, risulterà profeticamente eloquente. Canzone contro la società delle merci, il potere dei soldi che falsifica qualsiasi comunicazione, qualsiasi legame: Money doesn’t talk, in swear /Obscenity, who really cares/ Propaganda, all is phony (i soldi non parlano, bestemmiano /Oscenità, chi se ne importa /Propaganda, è tutto una finzione).
Advertising signs that con you/Into thinking you’re the one/That can do what’s never been done/That can win what’s never been won/Meantime life outside goes on/All around you. (Cartelloni pubblicitari ti inducono/a pensare che tu sei quello/che può fare ciò che non è mai stato fatto/che può vincere ciò che non è mai stato vinto/e intanto la vita fuori va avanti senza di te).
Dylan condanna la società commerciale e preserva la sua autonomia artistica e di pensiero, la scelta di una chitarra elettrica e di un amplificatore. Sarà questo il fonte della sua successiva produzione: la sua coscienza, la propria libertà creativa.
Like a rolling stone in Highway 61 revisited è una canzone che si rivolge a una donna cresciuta in ambiente d’élite che si ritrova tra i derelitti: Ah you’ve gone to the finest schools, alright Miss Lonely/But you know you only used to get juiced in it/Nobody’s ever taught you how to live out on the street/And now you’re gonna have to get used to it (“Hai frequentato le scuole migliori, certo, Signorina Solitaria / ma sai bene che l’unica cosa che tu sia riuscita a fare è sbronzarti /Nessuno ti ha mai insegnato a vivere sulla strada /E ora ti rendi conto che ti ci devi abituare”).
Una canzone che condanna l’opportunismo e l’ipocrisia, le gerarchie sociali e le squilibrate relazioni di potere. Una canzone che predica la vendetta, un controsenso nel contesto degli ideali di pace e armonia che in questo momento storico vengono elaborati dal folk rock americano. Ma in quel momento aveva ragione di esistere. Parlava la lingua che sarebbe servita ad accendere la rivoluzione. La sua, intanto, gli comanda di seguire la propria strada, di abbandonare l’immagine del profeta folk e di scegliere come essere: libero come una pietra che rotola.
https://www.youtube.com/watch?v=dxLMr784l0Q&spfreload=10
Nel 1965 al Newport Folk Festival Bob prende la decisione di eseguire i suoi pezzi con l’amplificatore. Proprio lì, nel cuore del tradizionalismo folk più convinto, con un pubblico che aspetta di ascoltare brani di impegno sociale. Si presenterà indossando un giubbotto di pelle nera e si esibirà in una versione rock di Maggies’ farm. Seguiranno fischi e contestazioni: l’anima del festival è un’altra, diranno. “E la chitarra elettrica rappresenta il capitalismo, la gente che si è venduta” [Sounes, p. 191]. Invece Dylan stava andando incontro al nuovo che con lui cominciava: la ribellione dalle convenzioni, dagli schemi, la ricerca di sé: I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more/Well, I try my best/To be just like I am/But everybody wants you/To be just like them (Non lavorerò più alla Fattoria di Maggie/ Ho fatto del mio meglio per essere proprio quello che sono/Ma tutti vogliono che io sia come loro).
Alla fine dell’esibizione non è difficile sentire le contestazioni del pubblico.
Invece lui aveva ragione. Qualche anno dopo, nel 1970, rock o non rock, la Princeton University gli conferirà la laurea ad honorem in musicologia “per aver espresso nelle sue canzoni – dirà il rettore – nella maniera più eloquente quei sentimenti contro la guerra che molti di noi provavano”. Nixon aveva appena ordinato alla truppe americane di attaccare le basi dei Vietcong in Vietnam. Operazione Rolling Thunder.
Nel 1974, con il suo Tour ’74 inaugura la stagione delle grandi tournée negli stadi dell’epoca del rock: la trasformazione in rock star è pienamente compiuta. Merito anche di brani che sono da subito memorabili come Knockin’ on Heaven’s Door, che scrive per il film western “Pat Garrett & Billy the Kid” diretto da Sam Peckinpah e interpretato anche da lui stesso. Il testo è il resoconto disilluso e stanco di uno sceriffo, ex bandito ormai invecchiato che ha davanti a sé il passato e l’amicizia con Billy the Kid in cui riflette la sua immagine: Mama, take this badge off of me, I can’t use it anymore (Mama, toglimi questo distintivo non posso più usarlo).
https://www.youtube.com/watch?v=_bWzyiU-S_w
Poi nuovi temi compariranno nei suoi testi. Nella metà degli anni Settanta maturerà la conversione alla religione cristiana. In Slow train coming (1979) racconta del suo ritorno alla fede. La rivista Rolling Stone scriverà: “La fede è il messaggio, la fede è il punto centrale. E la fede è la chiave per capire il disco”.
https://www.youtube.com/watch?v=Ijh42sc6P4E
Nel 1984 Dylan partecipa al Live Aid di Bob Geldof per raccogliere fondi a favore dell’Etiopia; il 13 luglio 1985 andava in scena il più grande concerto di musica leggera di tutti i tempi. Jack Nicholson lo presenterà dicendo: “Ci sono artisti le cui opere parlano per sé. Quelle di altri parlano per una generazione intera. E io ho il piacere di presentarvi una delle più grandi voci libere della libertà in America: Bob Dylan” (H.S., p. 367). Voce libera, voce della libertà.
Con Down in the groove (1988), venticinquesimo album pubblicato dalla Columbia Records, Bob inaugura una successiva fase della sua poetica, affronta nuovi temi, quello dell’alienazione, della vecchiaia e della morte. Not dark yet sembra il monologo di un uomo che si sta abbandonando alla morte. It’s not dark yet, but it’s getting there/Non è ancora buio ma lo sta diventando.
Ma la grandezza di Dylan è quella di sorprendere e lascerà a bocca aperta all’uscita di un prossimo suo album. Perché lui è un artista che non si è mai fermato, ha continuamente trasformato il proprio linguaggio musicale, le tematiche, le battaglie, le proprie convinzioni, se stesso. Un artista che ha scelto chi e come essere ogni volta, che ha saputo incarnare la voce collettiva dell’America ma che ha anche saputo mettersi a nudo, raccontando di sé, delle proprie paure e angosce, dei fallimenti personali, come i divorzi e le storie d’amore finite male. Le donne della sua vita non sono argomento di poco conto: Joan Baez, Suze Rotolo, Sara Lownds, Caroline Dennis, Mary Aloice Artes. Le canzoni a loro dedicate sono colme di una vasta gamma di emozioni, di realismo, di verità. Ma anche risentimento, frustrazione, scontro tra sessi. Ballad in plan D racconta della fine della sua storia con Suze: I once loved a girl, her skin it was bronze/With the innocence of a lamb, she was gentle like a fawn/I courted her proudly but now she is gone.
https://www.youtube.com/watch?v=nfZ-O25MR4w
Più tardi Where are you tonight sarà il rimpianto di un altro matrimonio finito, quello con Sara: There is a woman I long to touch and I miss her so much but she is drifting like a Satellite.
Nei testi di Dylan c’è la magia di versi capaci di generare visioni così forti da permanere nella memoria collettiva. Nella sua storia c’è la forza di una perenne rivoluzione, il rifiuto di una qualsiasi etichetta: né dell’autore di canzoni di protesta, o di canzoni politiche, o dell’autore impegnato per una causa piuttosto che un’altra, né dell’autore di canzoni d’amore, di canzoni sociali, del musicista folk o del musicista rock, del poeta o del cantautore, dell’imbonitore, del profeta o del veggente. Niente. La libertà soprattutto. Bob Dylan, e questo basti.
Chiara Ferrari, coautrice del documentario Cantacronache, 1958-1962. Politica e protesta in musica, autrice di Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati, edizioni Unicopli
Pubblicato lunedì 31 Ottobre 2016
Stampato il 20/04/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/dylan-la-perenne-rivoluzione-di-uno-nessuno-e-centomila/









