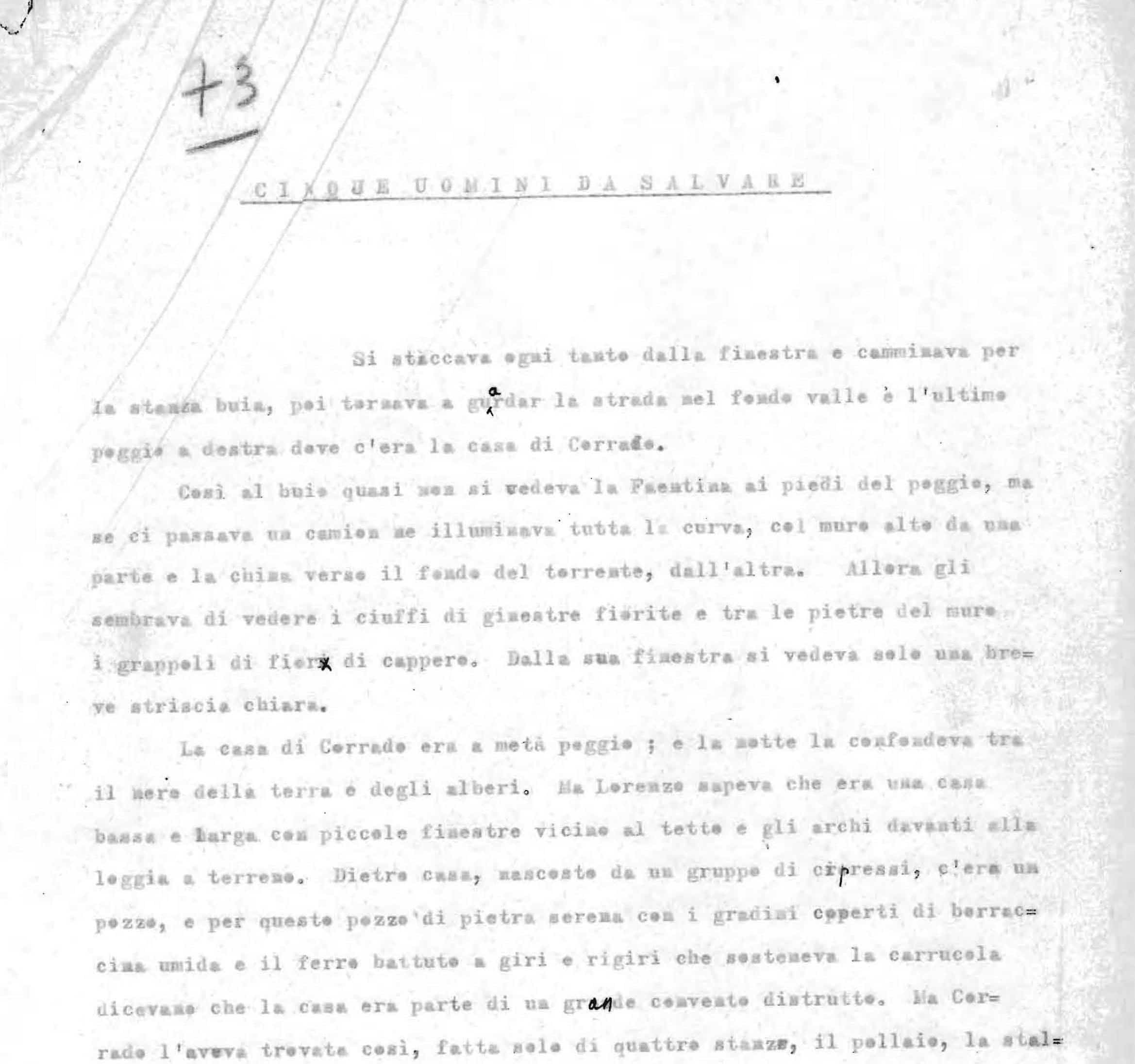 Negli archivi dell’Anpi nazionale, in corso di riordino, c’è una cartella di cartoncino rosa con la scritta “raccolta di racconti sulla Resistenza per il premio Prato anno 1952 inviati alla casa editrice Einaudi”. Dentro, qualche centinaio di fogli di carta sottilissima e ingiallita, tutti dattiloscritti, col colore dell’inchiostro mangiato dal tempo. Alcuni editi in passato, altri no.
Negli archivi dell’Anpi nazionale, in corso di riordino, c’è una cartella di cartoncino rosa con la scritta “raccolta di racconti sulla Resistenza per il premio Prato anno 1952 inviati alla casa editrice Einaudi”. Dentro, qualche centinaio di fogli di carta sottilissima e ingiallita, tutti dattiloscritti, col colore dell’inchiostro mangiato dal tempo. Alcuni editi in passato, altri no.
Scavando in questa miniera, scopriamo che “il premio letterario Prato è nato nel 1951 per iniziativa della locale sezione dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in relazione alla campagna diffamatoria promossa contro la Resistenza e in relazione all’incriminazione di alcuni partigiani di Prato, assolti poi in istruttoria” (dalla fotocopia di alcune pagine del volume “Scarpe rotte, eppur bisogna andar”, prefazione di Raffaello Ramat, Edizioni Avanti! 1955).
Nella seconda edizione dell’iniziativa (1952) fu presentato questo racconto di Franca Olivagnoli. Lo pubblichiamo perché, per farla breve, ci è parso davvero bello ed emozionante. Ci ha colpito per il linguaggio parlato, scarno, poetico, con cui si racconta una storia drammatica di partigiani e partigiane, di sensazioni e sentimenti. Una storia di intensa umanità. Una storia di Resistenza. Anche così facciamo memoria.
Patria Indipendente
Si staccava ogni tanto dalla finestra e camminava per la strada buia, poi tornava a guardar la strada nel fondo valle e l’ultimo poggio a destra dove c’era la casa di Corrado. Così al buio quasi non si vedeva la Faentina ai piedi del poggio, ma se ci passava un camion ne illuminava tutta la curva, col muro alto da una parte e la china verso il fondo del torrente, dall’altra. Allora gli sembrava di vedere i ciuffi di ginestre fiorite e tra le pietre del muro i grappoli di fior di cappero. Dalla sua finestra si vedeva solo una breve striscia chiara. La casa di Corrado era a metà poggio; e la notte si confondeva tra il nero della terra e degli alberi. Ma Lorenzo sapeva che era una casa bassa e larga con piccole finestre vicino al tetto e gli archi davanti alla loggia a terreno. Dietro casa, nascosto da un gruppo di cipressi, c’era un pozzo, e per questo pozzo di pietra serena con i gradini coperti di berraccina umida e il ferro battuto a giri e rigiri che sosteneva la carrucola dicevano che la casa era parte di un grande convento distrutto. Ma Corrado l’aveva trovata così, fatta solo di quattro stanze, il pollaio, la stalla dietro la loggia e il pozzo fra i cipressi.
l ragazzi della brigata si fermavano alla casa di Corrado prima di salire ai monti. A volte, per ordine improvviso, era Corrado che andava in montagna ma tornava sempre senza nemmeno riposarsi perché il suo posto, diceva, era alla casa.
Corrado era bravo partigiano e si poteva comandargli le cose più pericolose; faceva il partigiano con la stessa tranquillità e sicurezza con cui faceva il contadino. Voleva bene alla terra e nell’aiutare i ragazzi la difendeva. La casa, il grano, gli alberi potevano esser bruciati, ma c’era la terra da difendere, e l’amore per i campi dietro casa era amore per tutti i campi, per tutta la terra dei contadini del suo paese e del mondo. Per questo Lorenzo aveva scelto lui.
S’erano visti il venerdì al mercato di via Condotta. Lorenzo lo aveva trovato appoggiato al muro alla cantonata di Via de’ Cerchi; con le mani abbandonate nella cacciatora e lo stecchino fra i denti che andava ballando allegro come un filo d’erba al vento, da una parte all’altra della bocca.
Il mercato non era un gran mercato come quello dei bei tempi quando i contadini e i fattori arrivavamo da San Firenze fin quasi al Porcellino e invadevano anche parte di piazza Signoria; era un mercato molto più povero di gente, ma i contadini che c’erano urlavano egualmente di fieno, di lupinella, di grano e di fiore d’ulivo.
Corrado gli era venuto incontro appena lo aveva visto e avevano camminato fino a piazza Signoria parlando di fieno lupino di erba lupina. Nella piazza Corrado aveva alzato gli occhi alla torre, ma forse li aveva tenuti chiusi perché c’era troppo sole e non era possibile guardare il bruciato della torre contro l’azzurro schiarito del cielo. All’improvviso aveva chiesto: – Di nuovo? –. Diceva sempre così come se non potesse sprecar parole. Era un contadino robusto e sicuro.
– Portano via cinque dei nostri domenica notte; cinque uomini importanti. Passeranno dalla tua curva verso mezzanotte. Bisogna avvertire i ragazzi.
Ci vuole una macchina e le divise tedesche, lo sai già. Non dovrebbero essere troppo scortati, in ogni modo oltre ai ragazzi ai margini della strada tienne qualcuno in casa tua. Pensa tu a disporli al punto giusto.
Corrado aveva ascoltato gli ordini.
Uno dei cinque è all’ospedale e forse ne arriveranno solo quattro alla curva. Se va bene, il solito segnale.
Pareva molto più facile venerdì mattina. Ora, così a buio, a guardar quella valle meravigliosa dove le case più vicine paiono costruzioni di bambini, non è più facile. Passa una fila di camion e pare un gioco da ragazzi, un camion e una striscia quasi azzurra di luce, un altro camion e un’altra striscia quasi azzurra e la strada schiarisce e rabbuia e alle curve i motori s’infiacchiscono. Alla curva di Corrado illuminano un po’ di muro, un po’ di poggio e la casa. La casa di Corrado, con il suo letto da sposo, l’armadio grande per i vestiti, la tavola nodosa di cucina, la madia alta per il pane, il cassone per la farina… eppure è una casa partigiana; da lì si organizza, si smista la trafila, lì stanotte ci son ragazzi con i mitra a tracolla e bombe per ogni tasca. È una casa partigiana, tra un’ora può darsi che fosse bruciata.
– Son io che gli ho comandato questo; può rimetterci la casa e la pelle –.
Gli prende sgomento per questi suoi comandi: – Perché Corrado lo fa? perché gliel’ho comandato? che gli prometto in cambio? … L’undici e cinque: speriamo che tutto vada bene –.
Non sa dir altro ora.
È più facile mettere insieme, senza averlo mai fatto prima, 50 g di acido solforico a 58 B.C., benzina e benzolo per fare una bottiglia Molotov, incartarla, spargervi sopra potassio, zolfo, zucchero e poi gettarla contro un’autoblinda carica di tedeschi. È più facile perché non c’è da comandare; si può esser morti dopo qualche minuto ma non c’è da stare a una finestra a guardare una valle terribilmente tranquilla. I camion della Todt sono spariti dietro i poggi, Tornano buio e silenzio e lumi di lucciole da qualche parte nella valle. L’undici e dieci; c’è da aspettare, bisogna esser tranquilli. …Vaghe stelle dell’Orsa…Chissà se Nora è andata all’Antella?
Nora è la sua allieva che ha ritrovato partigiana. Porta ancora le trecce come al Liceo e i compagni la prendono in giro perché dicono che prima che Nora si sia pettinata i tedeschi hanno avuto tempo di far saltare tutta Firenze. Ma non è vero, perché Nora si pettina solo quando gli altri dormono, quando è sicura che non ci sarà bisogno di lei.
L’ha vista una notte sotto la loggia di Corrado. Era arrivata alle cinque in bicicletta con una cassa d’insalata marcia e di legna di casse spezzate. Sotto c’erano due mitra. Aveva dovuto passare due posti di blocco e aveva detto di aver raccattato da tutti gli ortolani della città l’insalata marcia per qualche gallina che aveva, e la legna per un po’ di fuoco. A casa di Corrado l’aspettavano col cuore in gola e invece era stata proprio brava. Faceva tutto con allegria e anche a lei, come a Corrado, pareva non costasse fatica. Aveva voluto dormire sul fieno sotto la loggia e lui e Gianni, il partigiano venuto a prendere i mitra, le tennero compagnia. Si era svegliato a meta notte e aveva visto Nora pettinarsi le trecce. Le carezzava coi pettine dalla divisa fino all’ultimo ricciolo, poi chinava la testa in avanti e faceva scivolare la mano tesa sui lunghi capelli neri, poi tornava a passarci il pettine come se coccolasse un bambino.
Non le aveva parlato pensando che le sarebbe dispiaciuto sapersi scoperta.
L’ha veduta nel pomeriggio, è venuta a raccontargli la liberazione del ferito dall’ospedale. Così saranno quattro gli uomini che passeranno dalla curva di Corrado. L’undici e venti, quasi. È inutile stare a fissar la strada, è ancora presto. Sergio ha detto che non passeranno sicuramente prima di mezzanotte.
All’ospedale à andata bene. Ci hanno pensato Ettore il dottore, e Nora che ha fatto la finta infermiera. Quando sono arrivati i ragazzi era già tutto pronto: i fili della luce e il fili d’allarme tagliati; quelli del telefono non ce n’era stato bisogno ché ancora la cabina fatta saltare due notti prima non era stata riattivata. Mitra puntato e su per le corsie. Nora gli dice che c’erano lunghe e bianche corsie con finestre alte dietro i letti al di là di tende di tela ingiallita dal sole. Anche il dottore passando per le corsie ha fatto finta di essere rapito. Ha camminato a forza, ha tentato di fuggire, ha tentato perfino di suonare un campanello d’allarme, ma l’hanno mandato avanti premendogli contro le spalle la canna del mitra. Nora era troppo contenta per far questo; ha camminato vicino al partigiano e ha lasciato che gli occhi le ridessero guardando i malati delle corsie. Anche quando è venuta da lui non ha saputo stare tranquilla lui ne era preoccupato, — Non sei stata imprudente, Nora? — perché imprudente? Davanti al portiere che so che è fascista, non ho battuto ciglio. – Sì, ma è meglio che tu vada via per due o tre giorni. Le trecce… ti possono riconoscere con più facilità di un uomo. Va’ all’Antella, sta un poco dalla tua nonna e poi torna –.
Ma Nora si era messa a parlare dei giorni di scuola, della buffa professoressa di francese, delle compagne che si erano sposate, dei bambini delle compagne, della sua saltata da pochi giorni, di suo padre ucciso, e ancora della mattina all’ospedale; e poi di dopo, quando non ci sarebbe stata più la guerra e lei avrebbe potuto finir di studiare e vivere la vita meravigliosa di dopo la guerra, la vita che anche lei stava preparando. – Pensi che cosa bella: giornali riviste teatro cinematografi uomini, tutto nuovo, pulito, appena nato – e moveva la mano come se avesse sentito scorrere dell’acqua così fresca da far sdrucciolare le dita. – Sono così contenta, professore, oggi è proprio una bella giornata. Avesse visto la gioia di quell’uomo che abbiamo portato via dall’ospedale! Pensi agli altri stasera. Vorrei esser lassù…. Mi dica qualcosa di molto bello, ora. Mi dica Leopardi, Silvia! – …Né teco le compagne ai dì festivi – ragionavan d’amore…–.
E c’era ancora il sole in quella stanza. Entrava dalle persiane chiuse e rigava l’impiantito. Nora s’era tolta le forcine che le fermavano il giro di trecce intorno alla testa. – È caldo – aveva detto – così fa più fresco – e le aveva lasciate scender giù per le spalle e appoggiarsi morbide contro l’azzurro della sua casacca di cotone. Era andata via quasi a notte. Da dietro la persiana l’aveva vista salire in bicicletta e pedalare verso la discesa. La casacca azzurra le si era gonfiata di vento. Anche a lei aveva comandato, anche lei era in pericolo: e in cambio?
Smise e guardare verso la casa di Corredo. Mosè a quest’ora era già salito a Vincigliata.
Era stato l’Intelligence Service a dare l’informazione precisa. Il “Norvegese” aveva fatto con astuzia il doppio giuoco e non si sarebbe mai tradito perché era troppo bravo, ma era una spia: sapeva troppe cose, troppe vite dipendevano da lui. Bisognava farlo fuori entro sabato notte. Lorenzo aveva incaricato Mosè.
Mosè era operaio ed era di dieci anni più vecchio di lui. Aveva cominciato a lavorare a sette anni e si era formata la coscienza saldando rotaie e stringendo bulloni lungo la strada ferrata. Si era fatto uomo sotto il sole che bruciava la nuca nei giorni d’estate, e sotto l’acqua che colava dal berretto, passava la mantellina d’incerato e inzuppava la camicia nei giorni di pioggia: si era fatto uomo con gli scioperi del ’20 e del ’21. Per questo lo aveva chiamato. – Porta un altro me vuoi, ma devi farlo tu– Mosè non aveva mai ucciso un uomo, forse nemmeno alla guerra del ’14. Ora doveva esser già salito col “Norvegese” fra lui e l’altro che avrà portato con sé per la strana stretta di Corbignano, su per il sentiero che va al bosco di Vincigliata.
Era un uomo buono e tranquillo Mosè, un uomo che provava un indignato stupore per tutte le cose cattive e soffriva per i ragazzi in montagna – perché possono morire – diceva. Pativa per questi ragazzi come aveva patito per gli operai bastonati a sangue nelle case e nelle strade, per quelli che morivano nelle carceri, per quelli costretti al confino, e per le Case del popolo, per le Cooperative bruciate, per la fatica dì migliaia di compagni bestialmente distrutta. Per il dolore di allora, per la pena pensosa che era diventata parte ai lui e gli aveva intristito e irrobustito la coscienza, Lorenzo lo aveva scelto. – Perché sia giustizia e non assassinio, devi farlo tu. – Mosè aveva detto di sì e stanotte su nel bosco ha ucciso un uomo. Con che diritto gliel’ha ordinato?
Gli è impossibile continuare a stare alla finestra a guardar la valle la strada le case che sembrano giochi da ragazzi. Esce dalla stanza, cammina al buio per uno stretto corridoio, nella cucina beve dell’acqua da un fiasco. Poi siede per terra appoggiato contro la gamba del tavolino e distingue dopo un poco sul camino mattonelle bianche disegnate di scuro; vorrebbe che fosse giorno per rivederne bene il disegno; e s’assopisce.
Ma non può star molto nemmeno lì e si alza col cuore che gli batte in gola per la paura d’essere stato appoggiato alla gamba del tavolino per delle ore e di aver lasciato passare mezzanotte, l’una, e il camion con i quattro uomini da salvare.
Improvviso gli par di sentire il primo colpo di un orologio e allora corre alla finestra sulla valle guardando attento, come se la luce alla svolta dovesse accendersi a quell’ora precisa. Mentre guarda pensa che in casa non ci sono orologi che suonano; allora gli torna alla memoria il rumore e s’accorge che era un colpo al cancello del giardino. Prende la rivoltella e scende. Riconosce subito Sergio.
Sergio era milite repubblichino, un milite repubblichino partigiano. Era un posto difficile perché bisognava essere bravi, molto cattivi e non tradirsi mai, nemmeno quando ci si credeva soli.
Era un ragazzo alto e biondo, con un lungo collo magro e bianco che usciva dalla camicia nera e lo faceva sembrare un ragazzo malato. Odiava la sua divisa ma aveva imparato a portarla bene, con cattiveria, e così pareva che fosse orgoglioso e ambizioso di portarla.
Nell’ottobre nel ’43, mentre era soldato, i fascisti gli avevano fatto uccidere tre compagni rientrati con dieci giorni di ritardo.
Era al di là del cancello e aveva poggiato la testa su una mano aggrappata alle sbarre. Sulla Bolognese, dietro casa, si sente rumor di motori; devono essere i Tigre perché la terrà è scossa fino al giardino della casa e i vetri delle finestre tremano. Sergio entra e Lorenzo richiude il cancello con la catena. Quando la porta è chiusa, i motori della Bolognese paiono un lontano ronzio d’aeroplani.
Dalla stanza sulla Faentiva i rumori non si sentono più. Lorenzo chiede: – Un contrordine? Una spia? – e vede nello stesso tempo la casa di Corrado in fiamme e Corrado impiccato al noce dietro la casa e Mosè con la faccia contro terra nel bosco di Vincigliata. – Una spiata? –.
– No, saranno su verso le due, credo; hanno tardato –.
– Che hai? –
– Sergio s’è seduto vicino al tavolo ma ha lasciato le braccia abbandonate verso terra e pare un ragazzo morto.
Lorenzo chiude la finestra e accende un mozzicone di candela. Sui muri si disegnano ombre allungate di mobili. Sergio alza il viso e fissa la candela. – Dammi un po’ d’acqua – chiede.
Senza pensare, appenato dalla stessa pena che opprime Sergio e sbigottito per questa pena che non sa, attraversa la stanza, cammina tastoni per il piccolo corridoio, prende il fiasco sul tavolo di cucina e lo porta a Sergio. La candela ripete sul muro un fiasco lungo e stretto. Sergio beve e l’acqua gli cade dai lati della bocca lungo il collo, sulla camicia nera.
– Non posso tornare laggiù –. E si asciuga la bocca col dorso della mano e poi si passa la mano umida sulla fronte. – Non puoi obbligarmi a tornare al Comando –.
Lorenzo ascolta i rumori della valle e fissa Sergio. Qualcosa è accaduto ma bisogna egualmente sentire il camion.
– Hanno riconosciuto Nora. L’hanno presa – .
Sergio racconta: – Non so dove l’hanno presa, non ho chiesto niente, l’ho trovata seduta su una sedia con un piede bruciato. Mi ha guardato quando sono entrato e io ho pensato per un attimo che mi sarei tradito, ma lei è tornata a fissar la parete. Volevano sapere dell’ospedale e lei guardava sempre la parete. Quando l’hanno frustata a sangue ha gridato. Sono restato a guardare perché il tenente ha detto che dovevo guardare –.
Ha teso le braccia sul tavolino e ci ha nascosto la testa: – Quel che non le hanno fatto – dice – e io ho visto, Lorenzo, ho visto… ho visto –.
Lorenzo spenge la candela e apre la finestra. Sergio continua a piangere ma non è un piangere: è un rantolo asciutto.
– Poi il tenente ha detto: – Se vuoi andartene, qualcosa hai già imparato –.
Nora allora mi ha guardato e mi pregato così di non lasciarla sola. Sono restato. Le hanno sciolto le trecce e le hanno bruciato i capelli.
Quando la fiamma le si è attaccata alla faccia le hanno buttato addosso una coperta e il fuoco si è spento. È restata un poco svenuta e poi ha riaperto gli occhi–.
Lorenzo non può più sentire: – Basta –. Sergio ha uno scatto: – Basta? Tu puoi dire basta e non la vedi; e io? No, non basta, ha fatto un’altra cosa Nora. A fatica ha alzato un braccio e si è cercata i capelli sul petto e la mano le si è rattrappita quando quando non li ha trovati; allora si è tastata su per il collo, fino all’orecchio. Si cercava le trecce. Quando si è accorta di non aver più trecce, di non aver più capelli, ha pianto a singhiozzi come una bambina, e poi s’è svenuta ancora e io sono scappato. Le hanno sparato dopo quasi un’ora –.
Sergio si alza e pare ubriaco, traballa nella stanza; guarda un poco la valle e poi torna, senza averla vista, al tavolo; seguita a piangere senza lacrime. Lorenzo guarda i monti in fondo e cerca la loggia di Corrado col fieno alto dove vi può dormire e risente, da lontano, restata con Nora, la propria voce: … né teco le compagne…
Non può dire a Sergio di non gridare perché Sergio ha ragione di gridare. – Sono un assassino, l’ho ammazzata io; dovevo sparare, dovevo portarla via – . Poi si volta irato contro Lorenzo: – Perché l’hai mandata all’ospedale? Non la dovevi mandare, era una bambina. Perché dopo non sei andato a cercarla e non l’hai tenuta con te? L’abbiamo ammazzata noi, l’ho ammazzata io –.
– Loro l’hanno ammazzata, Sergio; e non la devi chiamare bambina, non vorrebbe, avrebbe ragione di offendersi, era una partigiana come tu sei un partigiano –.
– Non importa ora quello che tu mi puoi dire, puoi raccontarmi tutto quello che vuoi; mandami dai ragazzi, io non posso tornare laggiù, non voglio… –.
– In guerra ognuno ha il suo posto, Sergio, ed è sempre un posto pericoloso. Non vuoi tornare? E chi può prendere il tuo posto? Chi ci darà le informazioni che tu puoi darci? Che faranno i ragazzi in montagna se non sanno più niente di quaggiù? Loro sarebbero inutili qui e tu lo saresti lassù –.
– Ma io non ce la faccio più – .
– È faticosa per tutti la guerra, Sergio. Si è fatto tardi, può darsi che stiano poco a passare e tu ora saresti utile al Colmando a prender ordini. Non siamo gente qualsiasi, non possiamo pensare a lei, ora – .
Sergio beve ancora dal fiasco e si alza. Lorenzo gli fa strada fino al cancello. Si abbracciano e si appoggiano per un attimo l’uno all’altro perché la vita del partigiano non è vita facile. Poi Sergio mette in moto la motocicletta e scende a tutto gas verso il Comando. Lorenzo torna ancora alla finestra.
Non sa da quanto è andato via Sergio, ma è sempre notte.
Passa un camion veloce davanti alle case più vicine. Improvvisa, quando il camion è alla curva di Corrado, s’accende una luce di fari. Lorenzo guarda, e tutte le pene, tutte le domande ora si sono quietate: ci sono rimasti quattro uomini da salvare la cui vita è preziosa e che hanno speranza di vita fin lì, dov’è arrivato il camion.
Vede quello che accade nitido come se fosse là coi ragazzi: sa quali sono gli uomini vestiti da tedeschi, sa quali sono quelli ai margini della strada nascosti dietro i ciuffi delle ginestre e dietro il muro dove ci sono grappoli di fior di cappero. I fascisti credono davvero che sia una macchina tedesca che le s’è guastato il motore; scendono al richiamo pronti ad aiutare, ma restano abbarbagliati dai fari; non fanno in tempo a capire, che i finti tedeschi puntano i mitra e sparano.
Arriva a Lorenzo l’eco dei colpi nella valle e pare un suono fioco di fuochi d’artificio che lontano scoppino in aria. Sembra a Lorenzo di vedere più luce. Vorrebbe riuscire a vedere il camion fascista ruzzolare giù per la china fino al torrente e quattro uomini correre verso la casa senza fermarsi, senza nemmeno sentire la fatica, vorrebbe vederne i volti per scoprirvi la gioia che Nora aveva indovinata. Così, fermo davanti alla finestra, fissando la casa di Corrado, pensando a Nora a Sergio a Mosè, Lorenzo aspetta.
La casa di Corrado si comincia a disegnare sul nero del poggio.
Si schiariscono le facciate delle case più vicine e i tetti restano ancora bui, gli alberi diventano macchie scure e i prati pozze d’acqua chiara. Lorenzo rincorre immagini e ha addosso tutta la stanchezza di quelli a cui ha comandato.
Limpido, come se fosse vero, un canto di gallo si allarga per la valle e arriva a Lorenzo; poi un altro canto di gallo e un altro ancora. Tre canti di gallo. – Nora, è andato tutto bene –.
Dietro la casa di Corrado è nato un ciuffo diritto di cipressi, al di la dei monti il cielo sbiadisce e diventa color cenere, in cima ai poggi ora c’è un albero e una striscia di luce, un altro albero e un’altra striscia di luce; è luce senza colore ma Lorenzo sa che fra poco si tingerà di gialla e nascerà un altro giorno sereno.
Senza fatica, a veder nascere quel mattino chiaro dopo una notte così penosa, Lorenzo capisce perché è accaduto ciò che è accaduto, sa perché ha comandato e perché Corrado ha rischiato e Mosè ucciso e Sergio è tornato al Comando e Nora è morta.
È accaduto perché gli uomini vogliono vivere da uomini.
“Non dimenticate né i buoni né i cattivi”
Pubblicato venerdì 26 Luglio 2019
Stampato il 26/04/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/cinque-uomini-da-salvare/







